IANVA: Viaggio al termine dell’Europa
 «Il Canone è qua»: si chiude così la traccia che dà il titolo all’ultimo lavoro dei genovesi IANVA, tra le realtà musicali più interessanti e complete dell’ultimo decennio italiano. Se diciamo complete è perché, in un’epoca d’imperante cachistocrazia e deculturazione artistica, ad un livello qualitativo musicale assai elevato IANVA aggiungono testi eccellenti, i quali sondano in profondità una civiltà intera, nelle sue luci così come nelle ombre. Canone Europeo è il loro ultimo album, preceduto dal dannunziano Disobbedisco! (2006), Italia Ultimo Atto (2009) e La Mano Di Gloria (2012). Canone Europeo costituisce in qualche modo la summa dei precedenti, raggiungendo una maturità che compendia molte delle linee di una carriera ultradecennale. Un album la cui premessa è forse il mini L’Occidente (2007): quattro tracce che sono autentiche sferzate al Pensiero Unico, sentieri alternativi diretti al cuore dell’Occidente, incursioni al termine dell’Europa, un’Europa molti differente da quella celebrata da certi maître-à-penser che imperversano oggi. «Quella fiaccola d’Atene che tu sai / difendila dal vento che verrà…» erano le ultime parole della title-track de L’Occidente. Una fiaccola che in Hellas, seconda traccia del Canone, giace «spenta nella brina». Che allora «possa il coraggio accendere presagio di un mattino». Hellas, la Grecia antica, paradigma della grandezza e imago della tragedia – effigie d’un Occidente, terra del tramonto e custode di un Canone che, sebbene sovente negato, vilipeso e oltraggiato, può tornare a risplendere. Ecco perché il viaggio di questo ultimo lavoro parte in quella Grecia che ha disseminato la nostra civiltà ed è stata la prima a subire la mannaia di un’Europa la cui madrelingua è di natura economica. Ne abbiamo parlato con Mercy, voce del gruppo insieme alla “musa archeofuturista” Stefania D’Alterio e già membro di gruppi come Il Segno del Comando (autori di uno splendido concept sul Golem di Meyrink) e Malombra. Prima di giungere al loro ultimo capolavoro, tuttavia, è bene fare qualche passo indietro, tornando alle origini del progetto, nonché alle sue radici musicali e culturali. Ed è la prima domanda che abbiamo posto a Mercy.
«Il Canone è qua»: si chiude così la traccia che dà il titolo all’ultimo lavoro dei genovesi IANVA, tra le realtà musicali più interessanti e complete dell’ultimo decennio italiano. Se diciamo complete è perché, in un’epoca d’imperante cachistocrazia e deculturazione artistica, ad un livello qualitativo musicale assai elevato IANVA aggiungono testi eccellenti, i quali sondano in profondità una civiltà intera, nelle sue luci così come nelle ombre. Canone Europeo è il loro ultimo album, preceduto dal dannunziano Disobbedisco! (2006), Italia Ultimo Atto (2009) e La Mano Di Gloria (2012). Canone Europeo costituisce in qualche modo la summa dei precedenti, raggiungendo una maturità che compendia molte delle linee di una carriera ultradecennale. Un album la cui premessa è forse il mini L’Occidente (2007): quattro tracce che sono autentiche sferzate al Pensiero Unico, sentieri alternativi diretti al cuore dell’Occidente, incursioni al termine dell’Europa, un’Europa molti differente da quella celebrata da certi maître-à-penser che imperversano oggi. «Quella fiaccola d’Atene che tu sai / difendila dal vento che verrà…» erano le ultime parole della title-track de L’Occidente. Una fiaccola che in Hellas, seconda traccia del Canone, giace «spenta nella brina». Che allora «possa il coraggio accendere presagio di un mattino». Hellas, la Grecia antica, paradigma della grandezza e imago della tragedia – effigie d’un Occidente, terra del tramonto e custode di un Canone che, sebbene sovente negato, vilipeso e oltraggiato, può tornare a risplendere. Ecco perché il viaggio di questo ultimo lavoro parte in quella Grecia che ha disseminato la nostra civiltà ed è stata la prima a subire la mannaia di un’Europa la cui madrelingua è di natura economica. Ne abbiamo parlato con Mercy, voce del gruppo insieme alla “musa archeofuturista” Stefania D’Alterio e già membro di gruppi come Il Segno del Comando (autori di uno splendido concept sul Golem di Meyrink) e Malombra. Prima di giungere al loro ultimo capolavoro, tuttavia, è bene fare qualche passo indietro, tornando alle origini del progetto, nonché alle sue radici musicali e culturali. Ed è la prima domanda che abbiamo posto a Mercy.
IANVA entra in scena nel 2005, con l’EP La Ballata Dell’Ardito. Esordio del quale, un paio d’anni fa, abbiamo rieditato su vinile e CD una versione abbondantemente ampliata di contenuti. Il cambio di titolo in MEMENTO X-C richiamava una duplice ricorrenza: il decennale di IANVA e il centenario italiano della Grande Guerra. Si concretizzava così, in differita, il nostro primo atto, per come originariamente ideato. Prima, cioè, che una serie di circostanze ci costringessero a ripiegare sul più modesto e, almeno nel 2005, realistico EP di tre brani.
Questa la cronologia ufficiale. Ma in concreto il progetto operava da quasi un paio d’anni, sebbene privo di una denominazione definitiva. E, soprattutto, di una formazione vera e propria. Tutto ruotava attorno a un seminale terzetto che, con denominazioni e collaborazioni variabili, aveva licenziato pochi brani, destinati per lo più a compilation di area industrial/apocalittica.
Il gruppo iniziò ad acquisire la sua identità “storica” solo con l’arruolamento di ulteriori elementi, ossia i musicisti a tutt’oggi coinvolti. Oltre, naturalmente, all’ingresso di Stefania, nella formazione e nella gestione comunicativa dell’intero progetto. Non solo gli uni e l’altra resero tecnicamente possibile la realizzazione di composizioni fino ad allora solo virtuali, ma grazie a loro IANVA assunse la sua fisionomia definitiva. Che è, ricordiamolo, quella di un nutrito ensemble. In controtendenza, dunque, rispetto a quell’attitudine a “minimizzare”, gli organici non meno degli arrangiamenti, peculiare dell’area stilistica entro la quale, almeno in un primo tempo, risultavamo compresi. Lo spunto iniziale arrivava, infatti, dalle cosiddette Grey & Brown areas. Perimetri abbastanza evanescenti entro i quali, in quei giorni, venivano inscritte variegate situazioni musicali. Il tutto nell’ambito della cosiddetta Cultura Apocalittica, a sua volta estesa a campi non necessariamente musicali. Secca ammetterlo perché nulla è più demotivante dell’analisi postuma delle occasioni perdute, ma allora sembrava una grande idea. L’unica, anzi, potenzialmente in grado di dare vita a un movimento artistico e aggregativo autenticamente antagonista. Nonché in perfetta sintonia con le inquietudini sociali proprie dei tempi che si andavano preparando.
Ma per ben servire una grande idea, ci si diceva, sarebbe occorsa una altrettanto grande “scena”. Una poderosa onda d’urto di “materiale artistico” in grado di sconfinare in territori sempre più “esterni” e fare ogni volta, idealmente, dei prigionieri. Un movimento di tal fatta non ha scelta fin da subito: o cresce o muore. È un’elementare legge di natura: nasci vulnerabile e immediatamente sei circondato da nemici e predatori. Devi solo decidere se fortificarti, addestrarti e diventare sempre più competitivo oppure farti fare a pezzi. Ignari che, da lì a poco, quello stesso ambiente avrebbe scelto in massa la seconda opzione, rafforzando e moltiplicando il fronte “nemico” con ogni sorta di autolesione comunicativa e disperdendo l’interesse mediante l’inflazione di prodotti dilettantistici, cercammo da subito di apportare il nostro contributo.
Il primo passo, a nostro avviso, consisteva nel trovare una via al genere che fosse, per ognuno, culturalmente plausibile. Come era stato fatto, piaccia o meno, all’epoca della discomusic, genere il cui successo stellare era stato garantito proprio dalla sua attitudine e disponibilità a lasciarsi declinare secondo molteplici sensibilità: nazionali, culturali, di genere… Così, da buoni italiani, iniziammo a radunare tutte le suggestioni storiche e narrative che potessero riuscire galvanizzanti o struggenti. Che trasmettessero orgoglio e senso di amor proprio ferito. Per altri italiani e non per un ipotetico pubblico globish al quale, a rigor di logica, il genere avrebbe dovuto essere avverso.
Ovviamente, l’impianto sonoro seguiva a ruota. C’erano determinati filoni sui quali ci si era già cimentati in passato ed altri nei quali il nostro paese si era ben distinto, riuscendo a creare riconoscibilissimi e apprezzati sottogeneri. La canzone d’autore in primis. Il tabarin e l’avanspettacolo, con la variante “colta” del Cabaret, dalle serate futuriste alle cantacronache negli anni della contestazione. L’arte della soundtrack, specie nelle pellicole cosiddette “di genere”. La primissima new wave italiana, quella ben prodotta e determinata a dare battaglia nelle classifiche. La tradizione “bombastica” del melodramma. L’astuzia emozionale di certa musica leggera d’antan. Lo storytelling, come si direbbe oggi, para-occulto e romanzesco (con derive d’appendice) di certo metal, progressive e dark sound peninsulare, che pure ho conosciuto a fondo. Persino i dispositivi di una certa dance nostrana che riusciva a suonare allo stesso tempo galvanizzante e melanconica…
Poi c’era naturalmente molto altro ad ispirarci: i Laibach e i loro “parenti italiani” Devil Doll. Il rock decadente dell’olimpo Bowie-Roxy-Sparks-Velvet/Reed. I loro discendenti diretti Ultravox, Magazine, Visage e via dicendo. Il Kraut Rock, specie nelle sue declinazioni più marcatamente mitteleuropee. Il post punk più virile e “guerrafondaio”: Stranglers, Killing Joke, Theatre of Hate/ Spear Of Destiny nonché, irrinunciabili, Adam and The Ants. Il folk pagano psichedelico degli anni Settanta. Il black metal più atmosferico. La profondità di Scott Walker. La visionarità di Peter Hammill. La desolazione di Nick Drake. La sensibilità di Marc Almond.
Tutto stava nel riuscire a travasare giuste proporzioni di tutti questi elementi in un impianto dark/folk/martial. In quest’ultimo ambito, oltre alle esperienze fondanti di Death In June e Sol Invictus, col senno del poi, i soli gruppi che ci abbiano influenzato davvero sono essenzialmente due: i Blood Axis e gli Orplid.
IANVA è l’antico nome di Genova. Quanto di questa città è entrato nella carne nei vostri lavori?
Molto. Anche più di quanto, ora come ora, vorrei. Ma funziona come per il patrimonio genetico: occorre farsi una ragione d’un lascito nel suo insieme, compreso ciò di cui si farebbe volentieri a meno. Intanto c’è la fin troppo ovvia eredità della scuola cantautorale cittadina. Nulla da ridire: senza di essa, in particolare De André e, en passant, i sostanziosi arrangiamenti che gli provvedevano Reverberi e Piovani nella prima metà della carriera, IANVA non esisterebbe.
Detto ciò, vado a togliermi un paio di macigni dalle scarpe. Ormai parlo di rado di cantautorato genovese perché a quella tradizione si riferisce una più meno vivacchiante scuola cittadina “contemporanea”. Bene: pare sia stato stabilito, non so bene da chi e a quale titolo, che al di fuori di essa la scuola genovese non abbia eredi. Prendo nota. Acclarato che là in mezzo noi non esistiamo, non perdo neppure un minuto prima di dichiararlo un punto d’onore. Anzi, considerata la più assoluta irrilevanza della suddetta cerchia al di fuori del duplice perimetro cittadino e politico, verrebbe la tentazione di considerarlo persino di buon augurio. In secondo luogo, da qualche anno ho di molto ridimensionato la portata del magistero di De André. Non certo sul piano stilistico e poetico, che, al contrario, resta inarrivabile, quanto su quello etico. Con il senno del poi, sotto questo profilo, mi mancano molto di più un Gaber o un Battisti. Meno anarco-chic e ben più realisticamente consapevoli di quanto schifo possa fare la vita e di quanto male possa infliggerti la gente, povera o ricca che sia.
 Dico ciò perché vivo in una città che determinate ideazioni le ha fatte profondamente proprie. Al punto che, a forza di parteggiare per ogni sorta di diversità e marginalità, comprese quelle più oggettivamente irredimibili e schifose, si è ritrovata a essere una vera cloaca a cielo aperto. Di ciò dovremmo ringraziare certi venerati maestri la cui memoria è a tutt’oggi un intoccabile altarino. Genova è, almeno nella percezione collettiva, né più né meno che un’emanazione delle loro menti. Nella realtà concreta, invece, è un luogo dove ormai stanno per saltare le ultime staffe che fissano una comunità alle regole minime della convivenza civile. Temo altresì che qualche ripensamento politico dell’ultima ora non valga certo ad arginare uno sfacelo che ormai sospetto secolare e che riesco a scrutare persino in certe fisionomie che incrocio lungo la strada. Essendo comunque la nostra una delle città più antiche del bacino occidentale, qualcuno potrebbe obiettare che dovrebbe esserci ben altro nella nostra storia in grado di procurarci la nostra dose di orgoglio. In effetti è così, e basta vedere il marchio che accompagna il nostro logo per rendersene conto. Ma è dura constatare quotidianamente che tutta quella passata grandezza è unicamente affidata alla testimonianza della pietra. E pure quella non è tenuta in gran conto dai multiculturalissimi eredi della gloriosa repubblica.
Dico ciò perché vivo in una città che determinate ideazioni le ha fatte profondamente proprie. Al punto che, a forza di parteggiare per ogni sorta di diversità e marginalità, comprese quelle più oggettivamente irredimibili e schifose, si è ritrovata a essere una vera cloaca a cielo aperto. Di ciò dovremmo ringraziare certi venerati maestri la cui memoria è a tutt’oggi un intoccabile altarino. Genova è, almeno nella percezione collettiva, né più né meno che un’emanazione delle loro menti. Nella realtà concreta, invece, è un luogo dove ormai stanno per saltare le ultime staffe che fissano una comunità alle regole minime della convivenza civile. Temo altresì che qualche ripensamento politico dell’ultima ora non valga certo ad arginare uno sfacelo che ormai sospetto secolare e che riesco a scrutare persino in certe fisionomie che incrocio lungo la strada. Essendo comunque la nostra una delle città più antiche del bacino occidentale, qualcuno potrebbe obiettare che dovrebbe esserci ben altro nella nostra storia in grado di procurarci la nostra dose di orgoglio. In effetti è così, e basta vedere il marchio che accompagna il nostro logo per rendersene conto. Ma è dura constatare quotidianamente che tutta quella passata grandezza è unicamente affidata alla testimonianza della pietra. E pure quella non è tenuta in gran conto dai multiculturalissimi eredi della gloriosa repubblica.
Piuttosto, se proprio devo concedermi qualche nostalgia, rievoco una Genova persino più orrenda di quella contemporanea, ma nella quale riesco almeno ad alloggiare qualche tenero ricordo personale. E cioè quella del triangolo industriale, del milione di abitanti, del coro di sirene che alle cinque della sera riversava nelle strade migliaia di operai e di operaie in uscita dalle fabbriche. Era una città tetra, ventosa, annerita dai fumi, sfregiata fin oltre lo scempio dall’industrializzazione e dall’urbanizzazione a tappeto. Ma anche piena di gente coraggiosa, pratica, rude e infaticabile. Orgogliosa del proprio saper lavorare e non solo di uno scemenziario pararesistenziale a base di Jovanotti, Don Gallo e Manu Chao.
Oggi restano solo le cicatrici urbanistiche. Intere aree post-industriali che più nessun piano di recupero potrà trarre da un degrado ormai conglomerato con lo stesso suolo. Quartieri atroci costruiti a rotta di collo per alloggiare la forza lavoro arrivata da fuori. Slittanti su pendenze d’argilla e con mura di cartone che divergono quando piove. Popolosi come piccole città, ma collegati da viottoli che per ostruirli basta una carriola. Fabbriche di marginalità, infelicità, abbrutimento, malattia mentale. La caratteristica attitudine artistica cittadina consiste nel compiacersi delle suddette cose. Di trovarci un che di peculiare, edificante e persino di bello. Non è certo il caso nostro.
Come descriveresti la vostra evoluzione, da Disobbedisco a Italia Ultimo Atto, da La Mano Di Gloria a L’Occidente, fino a quest’ultimo lavoro?
La definirei cauta perché, come chiunque tenga a lavorare per il durevole, abbiamo tenuto al guinzaglio quella smania di novità continua che è uno dei tratti distintivi di questi nostri tempi. Tale premessa potrebbe indurre il sospetto che noi si sappia fare un’unica cosa. E che una dichiarazione di coerenza stilistica tanto frontale sia, in realtà, una formula come un’altra per fare di necessità virtù. Ma, come può testimoniare chiunque conosca un minimo la nostra produzione, IANVA è un progetto tutt’altro che monocorde. Al punto che i costanti correttivi stilistici risultano meno appariscenti di quanto effettivamente dovrebbero. Proprio perché s’innestano su un materiale sonoro già eclettico di suo. Se è vero, dunque, che abbiamo perseguito una cifra stilisticamente riconoscibile, lo è altrettanto che per ottenere il nostro suono occorre padroneggiare una quantità non comune di generi e sottogeneri. E credo che questa sia già, di per sé, una variazione sul tema.
Se un “profano” dovesse accostarsi per la prima volta a IANVA, cosa gli consiglieresti?
 Gli raccomanderei di accorpare gli ascolti di Disobbedisco! e Memento/La Ballata Dell’Ardito. Non solo in quanto tematicamente collegati e consequenziali come filo narrativo. Ma anche perché costituiscono un esaustivo compendio di tutte le ispirazioni musicali, estetiche e ideali relative alla prima fase del progetto. Compresi i membri e collaboratori che non sarebbero poi andati oltre questo primo shot. Non è un caso che i seguaci del neofolk canonico considerino questo periodo come il migliore. Tuttavia, credo che anche loro convengano che non saremmo mai durati fino ad oggi se avessimo insistito su identica falsariga. Invece, già L’Occidente costituì un precoce intermezzo di riflessione sulla materia sonora, più ancora che su quella concettuale. È vero che si tratta solo di un EP, ma lì ci riuscì di venire a capo di alcune inveterate incognite tecniche. Nonché di certe approssimazioni che orecchie professionali avevano comunque percepito su Disobbedisco!. Tecnicamente parlando, infatti, L’Occidente è stato il modulo grazie al quale ci è stato poi possibile realizzare i lavori successivi. Italia Ultimo Atto lo considero il nostro titolo più rappresentativo. Lo consiglierei a coloro che da un singolo disco si aspettano di scoprire tutto ciò che è necessario sapere sul conto di una band. Nessuna delle corde a noi congeniali viene trascurata e ogni declinazione possibile del nostro suono viene presa di petto e quasi “inchiodata” a funzionare!
Gli raccomanderei di accorpare gli ascolti di Disobbedisco! e Memento/La Ballata Dell’Ardito. Non solo in quanto tematicamente collegati e consequenziali come filo narrativo. Ma anche perché costituiscono un esaustivo compendio di tutte le ispirazioni musicali, estetiche e ideali relative alla prima fase del progetto. Compresi i membri e collaboratori che non sarebbero poi andati oltre questo primo shot. Non è un caso che i seguaci del neofolk canonico considerino questo periodo come il migliore. Tuttavia, credo che anche loro convengano che non saremmo mai durati fino ad oggi se avessimo insistito su identica falsariga. Invece, già L’Occidente costituì un precoce intermezzo di riflessione sulla materia sonora, più ancora che su quella concettuale. È vero che si tratta solo di un EP, ma lì ci riuscì di venire a capo di alcune inveterate incognite tecniche. Nonché di certe approssimazioni che orecchie professionali avevano comunque percepito su Disobbedisco!. Tecnicamente parlando, infatti, L’Occidente è stato il modulo grazie al quale ci è stato poi possibile realizzare i lavori successivi. Italia Ultimo Atto lo considero il nostro titolo più rappresentativo. Lo consiglierei a coloro che da un singolo disco si aspettano di scoprire tutto ciò che è necessario sapere sul conto di una band. Nessuna delle corde a noi congeniali viene trascurata e ogni declinazione possibile del nostro suono viene presa di petto e quasi “inchiodata” a funzionare!
Quanto a La Mano Di Gloria?
A mente fredda, lo reputo un vero azzardo. Ma che sono ben felice di aver fatto. Il disco in sé partì azzoppato da alcuni handicap di non poco conto. Il primo: il plot che collegava i vari brani era riferito all’omonima saga narrativa.
La quale, tuttavia, sarebbe stata pubblicata mesi dopo…
Al momento dell’uscita del disco, era ancora ben lontana dal vedere la luce. Quando finalmente mi riuscì di concretizzarla e, attenzione, non si parla di un tascabile, ma di un cofanetto in tre volumi per una somma di quasi 2100 pagine, molta gente iniziò a vederci più chiaro. Ma, nel frattempo, si era ritrovata tra le mani un disco concept il cui filo narrativo era apparso sulle prime non poco confuso.
Un secondo accidente era conseguito dal fatto che, nei mesi della realizzazione, nessun membro era stato in grado di seguire con sufficiente cura i lavori, compreso il sottoscritto, sequestrato dalla fatica libraria. Ciò comportò l’affidarsi alle cure di un fonico esterno, tecnicamente molto valido, ma lontanissimo per gusti e formazione dalle cose che avevano sempre fatto il “suono IANVA”. Il risultato poteva talvolta approssimarsi a un più canonico folk rock con venature alternative. Ma in altri frangenti emergevano interessanti spunti psichedelici, dei quali prendemmo debitamente nota.
Da ultimo, per dovere di verità e fottendomene di quanto ciò possa risultare poco signorile, debbo dire che, alla sua uscita, La Mano Di Gloria dovette vedersela immediatamente con una ben orchestrata campagna di odio nei nostri confronti. Oggi la definirebbero uno shitstorm. Non c’è che dire: almeno in una cosa a questa gente è riuscito di essere un passo avanti a tutti… Nella merda, per l’appunto. E se qualcuno volesse illudersi si sia trattato di un prevedibile linciaggio politico, sbaglierebbe di grosso: era tutta farina di sacchi di drogherie assai vicine alla nostra, per non dire attigue…
 In quei giorni ne abbiamo viste di incredibili. Portali che nascevano e morivano con un unico contenuto, ossia la stroncatura del nostro disco. Pagine Facebook in cui si assicurava che il disco era una ciofeca prima ancora che uscisse fisicamente. Altre in cui si ribadiva per intere giornate quanto facessero schifo gli IANVA e quanto fossero sfigati, perdenti e pezzenti, anche se si parlava di vino o calcio. Almeno un risultato, però, l’hanno ottenuto: distruggere e disperdere completamente ciò che restava di una scena, senza per altro riuscire a far fuori noi. E, tuttavia, non ristamperò più quel disco. Non perché tema di non venderlo, visto che alla fine è sold-out. Ma perché ormai risulta indissolubilmente legato al libro, anch’esso in via di esaurimento. Ristamparlo avrebbe senso unicamente in un’edizione che comprendesse entrambi. Impresa divenuta nel frattempo economicamente e gestionalmente pesantissima. I tempi sono quello che sono e io non posso che camminare per quanto sono lunghe le mie gambe. Peccato, perché là dentro ci sono alcune delle nostre pagine meglio scritte di sempre. E che, almeno per quanto mi riguarda, gridano vendetta.
In quei giorni ne abbiamo viste di incredibili. Portali che nascevano e morivano con un unico contenuto, ossia la stroncatura del nostro disco. Pagine Facebook in cui si assicurava che il disco era una ciofeca prima ancora che uscisse fisicamente. Altre in cui si ribadiva per intere giornate quanto facessero schifo gli IANVA e quanto fossero sfigati, perdenti e pezzenti, anche se si parlava di vino o calcio. Almeno un risultato, però, l’hanno ottenuto: distruggere e disperdere completamente ciò che restava di una scena, senza per altro riuscire a far fuori noi. E, tuttavia, non ristamperò più quel disco. Non perché tema di non venderlo, visto che alla fine è sold-out. Ma perché ormai risulta indissolubilmente legato al libro, anch’esso in via di esaurimento. Ristamparlo avrebbe senso unicamente in un’edizione che comprendesse entrambi. Impresa divenuta nel frattempo economicamente e gestionalmente pesantissima. I tempi sono quello che sono e io non posso che camminare per quanto sono lunghe le mie gambe. Peccato, perché là dentro ci sono alcune delle nostre pagine meglio scritte di sempre. E che, almeno per quanto mi riguarda, gridano vendetta.
E così giungiamo a Canone Europeo…
È difficile parlarne perché è storia di questi giorni. Io credo sia il nostro miglior disco in senso assoluto, sebbene si sia giunti a questo risultato sulla scia di uno stato d’animo ben differente rispetto al passato. Lo ammetto e non senza rammarico: per la prima volta la freddezza e il cinismo hanno pesato almeno quanto l’ispirazione. Non solo perché abbiamo tratto debite conclusioni da errori commessi nel recente passato. Ma anche perché tra La Mano Di Gloria e Canone Europeo è cambiata la nostra percezione.
Abbiamo lavorato lungamente, con estrema calma. Non c’era più tutta questa impazienza di riproporci: solo un enorme bolo di disgusto da smaltire! Se prima di La Mano Di Gloria ogni volta che ci si apprestava a uscire c’era tutta la felicità e l’eccitazione che si prova nel ritrovare degli amici, a questo giro l’abbiamo fatto con il coltello tra i denti. Come per una ricognizione in territorio ostile. La bella favoletta della Scena unita, dove ci si dà una mano e in cui ci sono solo brave persone, era finita per sempre. Ora mi dico che, in realtà, era così anche prima. Credere che potesse esistere qualcosa d’altro e di più è stata solo una mia madornale ingenuità.
Il risultato, tuttavia (lo dico da ascoltatore), è eccezionale. È davvero il vostro album migliore. Retto, tra l’altro, da un autentico manifesto che a un tempo denuncia lo stato delle cose e indica una possibile fuoriuscita. «Il Canone è una stella fissa che giganteggia nel vuoto che ci hanno approntato». È forse in queste parole, contenute nel booklet, che si condensare il Canone?
Certamente. Non a caso tendo sempre a far notare quanto IANVA abbia lavorato in questi anni sulla materia della memoria. Tutta la nostra insistenza sulla dimensione epica o “eroica” a monte di ogni narrazione possibile non è, in fondo, che una sorta di dispositivo che abbiamo imparato a maneggiare con una certa destrezza. Ma il nostro primario materiale di lavoro resta la memoria, che infatti è la facoltà epica per eccellenza. Solo in virtù d’una vasta memoria epica una cultura può da un lato appropriarsi del corso delle cose e dall’altro riconciliarsi con il loro scomparire, con la potenza della morte.
Come certo saprai, Mnemosine, colei che ricorda, era per i Greci un’attribuzione della Musa dell’Epica. Ed è logicissimo: persino il narratore più avvincente, il cantore più vibrante e sensibile sarebbero nulli se deprivati della più nobile e necessaria tra le materie prime di cui il loro lavoro necessita. Ossia il corpus delle idee e delle memorie “matrice”. E in queste memorie non sono compresi unicamente eventi, veri o mitici, o biografie. Ma le stesse strutture mentali, tutta “l’indicizzazione” dei codici psichici ed estetici, quel repertorio simbolico che definisce radici, origini ed appartenenze.
Non credo possa esistere una civiltà senza miti fondanti. E se esiste non è una civiltà. Nemmeno, come accade nella nostra epoca, se tenta in extremis di assegnarsene alcuni. Il che è pure peggio, perché una società che nasce laica e dissacrata fin dalle fondamenta finirà sempre per sintetizzare miti che le somigliano. Ora: potrebbe pure essere che tutto ciò non rappresenti altro che l’affannosa ricerca di un senso così come può concepirla un uomo disperatamente scettico, ma qualcuno ha idee migliori? È così complicato capire che la scienza, la tecnologia e tutto il ciarpame umanista di cui sono infarciti i sistemi educativi e la comunicazione non potranno mai liberare dalla paura dell’abisso, del nulla, ma semmai moltiplicarla?
Noi abbiamo scelto la preservazione di una piccola porzione di memoria. L’oculata custodia del modesto paragrafo di Canone che ci è toccato in sorte. Mi accontento di questo e, francamente, di meglio non so fare.
Ecco, il Canone… Il critico Harold Bloom ci regalò anni fa un Canone occidentale, e insieme una corrente antagonista ad esso, la cosiddetta scuola del risentimento. Una scuola orrenda, bigotta e moraleggiante quand’anche si dichiari “libertaria”, che disconosce il primato dell’estetica, piegandola a morali, filosofie, politiche e altre aberrazioni di questo tipo… Un meccanismo che ha finito per privilegiare senza discernimento la semplice appartenenza a minoranze (sempre più irreggimentate e organizzate dal sistema) o il trattare certe tematiche à la page… Eppure, come antidoto a quest’atrofia del giudizio estetico, è sempre la parola “stile” a risuonare nei vostri lavori. Uno stile che non è realtà di ieri. Il canone è qua. Non va resuscitato, è sufficiente soffiare sulla brace, andando in cerca di quelle consonanze cantate nella title-track, il segreto accordo di Busseto e Bayreuth…
Se per combinazione ti ritrovi a essere, come Harold Bloom, docente alla Yale University negli anni Settanta, il gioco è fatto! Hai assistito in diretta alla nascita e allo sviluppo della pestilenza direttamente nel suo focolaio originario. Come darti torto se poi spendi il resto della vita cercando di ostacolare la diffusione del morbo? Sennonché, ciò che alla sua integrità di studioso risultava deprecabile, se non addirittura oltraggioso, era il diretto risultato della penetrazione nei contesti istituzionali di quella Controcultura che, già in diretta, l’establishment intellettuale si era affrettato, paternalisticamente, a vellicare.
Capisco che per un americano ciò potesse rappresentare una spiacevole novità, ma allora cosa avremmo dovuto dire noi? Nell’Italia liberata a “protezione” statunitense certe ripartizioni erano iniziate già nel primo dopoguerra. Per intenderci, con quei famosi patti di desistenza che assegnavano alla componente social-comunista della nuova classe dirigente il monopolio della cultura, dell’editoria alta, dell’istruzione… Figurarsi dopo il ’68, quando per un buon decennio il modello virtuoso a cui guardare era la Rivoluzione Culturale Maoista. Per cui, mentre il buon Bloom si danna l’anima perché gli stanno imponendo di far fuori dai programmi, che so, Mark Twain o Melville in quanto sospetti razzisti, per fare spazio a certi illeggibili contemporanei solo perché appartenenti a minoranze “di comodo”, qui da noi un famosissimo accademico di cui non farò il nome già ritira ogni mese il suo stipendio da docente. Versatogli, in condizioni di costante assenteismo, da quello stesso Stato del quale predica in cattedra l’abbattimento violento. E senza che ciò determini alcun imbarazzo in nessuno dei soggetti coinvolti: lo Stato stesso, il Professore, i cittadini che attraverso le tasse si cavano di tasca il suddetto stipendio. Questo per dire quanto fosse già a dir poco pleonastico parlare di stile: in una società che tenesse ancora un minimo di conto il decoro, almeno uno dei tre soggetti avrebbe sollevato la doverosa obiezione.
Non so se è chiaro: mentre negli USA, direttamente nelle centrali culturali dove si formano le classi dirigenti planetarie, si stava preparando il salto di paradigma, qui da noi si era già tranquillamente oltre. Ciò dimostrerebbe, per esempio, quanto sia verosimile l’ipotesi che vede l’Italia come laboratorio dell’Occidente. Il terreno ideale, date l’amoralità diffusa e l’assoluta indifferenza nei confronti del cosiddetto bene pubblico, per gli esperimenti d’ingegneria sociale.
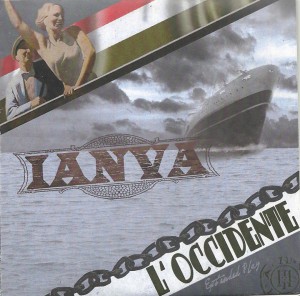 Secca ammetterlo, ma la stragrande maggioranza dei nostri concittadini diamola pure per persa. Basti osservare che genere di fenomeni hanno fatto breccia in modo massivo nell’immaginario dei nostri contemporanei: social network, selfie, estetiche e condotte “tropicalizzate” e musiche conseguenti, da ballo collettivo in spiaggia, vestiari pacchiani, cafoneschi o puttaneggianti, tatuaggi come se fossimo in una colonia penale della Cayenna, iniezioni di botox anche se sei cassiera alla Coop e l’unica telecamera che t’inquadra è quella a circuito chiuso, di sorveglianza… Eppure nessuno trova volgare, discriminatorio, sessista, razzista, diseducativo, non-ecologico, neo-colonialistico, banalizzante e livellatore tutto ciò. Che invece, guarda caso, lo è fino al midollo. Non le statue di Cristoforo Colombo o del Generale Lee… Personalmente, credo sia in atto una guerra di nuovo genere, il cui campo di battaglia è la sfera percettiva. Ed è una guerra cruciale perché gli esiti non decideranno solo gli assetti socio-economici futuri, ma anche la configurazione antropologica che il genere umano finirà per darsi. Dunque, vista l’entità della posta in gioco, non mi preoccupa più di tanto il fatto che le masse rispondano tanto prontamente agli input comunicazionali tendenti a renderli dei terzomondiali digitalizzati. Quanto piuttosto la penuria di cervelli, idee e risorse economiche per tentare di entrare in partita che caratterizza il versante “critico” o di opposizione.
Secca ammetterlo, ma la stragrande maggioranza dei nostri concittadini diamola pure per persa. Basti osservare che genere di fenomeni hanno fatto breccia in modo massivo nell’immaginario dei nostri contemporanei: social network, selfie, estetiche e condotte “tropicalizzate” e musiche conseguenti, da ballo collettivo in spiaggia, vestiari pacchiani, cafoneschi o puttaneggianti, tatuaggi come se fossimo in una colonia penale della Cayenna, iniezioni di botox anche se sei cassiera alla Coop e l’unica telecamera che t’inquadra è quella a circuito chiuso, di sorveglianza… Eppure nessuno trova volgare, discriminatorio, sessista, razzista, diseducativo, non-ecologico, neo-colonialistico, banalizzante e livellatore tutto ciò. Che invece, guarda caso, lo è fino al midollo. Non le statue di Cristoforo Colombo o del Generale Lee… Personalmente, credo sia in atto una guerra di nuovo genere, il cui campo di battaglia è la sfera percettiva. Ed è una guerra cruciale perché gli esiti non decideranno solo gli assetti socio-economici futuri, ma anche la configurazione antropologica che il genere umano finirà per darsi. Dunque, vista l’entità della posta in gioco, non mi preoccupa più di tanto il fatto che le masse rispondano tanto prontamente agli input comunicazionali tendenti a renderli dei terzomondiali digitalizzati. Quanto piuttosto la penuria di cervelli, idee e risorse economiche per tentare di entrare in partita che caratterizza il versante “critico” o di opposizione.
Noi facciamo del nostro meglio, ciò che è nelle nostre forze per cercare di addensare ideazioni, energie. Il nostro lavoro è come quello di certi enzimi che favoriscono la moltiplicazione degli anticorpi negli organismi malati. Mediante il rilascio d’immaginari radicalmente inversi rispetto a quelli correnti. Purtroppo dobbiamo anche vedercela con una sindrome sociale ulteriore e relativamente recente. Una sorta di deficit di attenzione di massa che rende sempre più difficile veicolare messaggi appena più articolati di uno slogan, un meme, una foto, un’illustrazione chiassosa, una rima baciata ottenuta da quattro vocaboli elementari. E anche questo è un bel guaio.
Nel cuore di tenebra del Novecento Martin Heidegger auspicò un ritorno ai Greci, “pensando ancora più greco dei Greci stessi”. Una Patria perduta, sorpresa dall’Europa burocratica ed etnocida prima che dal filosofare contemporaneo…
Potremmo addirittura affermare che oggi assistiamo a una sorta di moltiplicazione di paradigma. Rispetto all’epoca dei Romantici, infatti, resta immutato il concetto di Patria Psichica. Nel senso che l’antichità classica attribuiva al termine “psiche”, domicilio spirituale non controindicato neppure a campioni di tormentato scetticismo occidentale quali un Byron, uno Shelley o un Foscolo. Ma già quando Heidegger si accalora attorno a questo concetto ed esorta a rigrecicizzare a fondo l’impalcatura mentale europea, ovvero a ridimensionarne la componente giudaico-cristiana, con particolare enfasi sugli aspetti più fideistici di quest’ultima, la Grecia nuovamente indipendente appare ormai irrimediabilmente “orientalizzata”. E tuttavia non era ancora immaginabile la devastazione permanente instaurata da un laicismo ad un tempo estremo e impersonale che solo una tecnocrazia apolide può mettere a punto.
Dunque, la Grecia inizia ad apparire quasi come un’immagine in divenire dello smarrimento di senso in cui stiamo incorrendo. E anche in questo caso, come tu stesso hai acutamente precisato, ci soccorre Heidegger. Forse ancor più l’Heidegger “ulteriore”, quello successivo alla cesura. Mi torna in mente, in particolare, il suo concetto di oblio dell’essere. In certi passaggi pare effettivamente anticipare con esattezza quell’opprimente intramondano, quello stordimento dell’Uguale che è la cifra saliente della comunicazione contemporanea. L’etere in cui si disperde il distratto uomo radar iper-connesso che tutti ormai conosciamo. L’Esserci di Heidegger, al contrario, somiglia a una bussola che punta ad un centro interiore, al più autentico poter-essere. Al tempo in cui scriveva, la Grecia, intesa come forma-pensiero, appariva ancora come un credibile polo magnetico, ma oggi?
Quel che è certo è che il sistema entro il quale siamo rinchiusi smantella ogni stabile struttura temporale, frammenta il tempo della vita e disintegra tutto ciò che ha carattere vincolante, al fine di eliminare ogni possibile interferenza alla produttività. Esiste, in altri termini, una “politica del tempo” neoliberista che si avvale dell’angoscia e dell’insicurezza per incrementare l’efficienza, e ciò rende estremamente difficile tornare a ragionare in termini di perennità.
La figura di Ernst Jünger attraversa tutti i vostri lavori, fil rouge che si dipana ed emerge in capolavori come Negli Occhi D’un Ribelle o L’Anarca. Ed è il Ribelle a ritornare nel Canone in Come Ferro Battente, osservatore disincantato e distaccato di ciò che accade. Un’apolitìa che sembra costituire l’unica condotta da mantenere in un’epoca come la nostra…
Ernst Jünger è per me una sorta di pietra angolare. La figura del Waldgänger da lui tratteggiata è stata un modello, a un dato momento persino ingombrante, della mia formazione giovanile. Di recente ho letto, finalmente adeguatamente tradotta, La battaglia come esperienza interiore, e a tratti ho risentito il sangue dei diciott’anni pulsare nelle vene. Lo sventato coraggio, la prodezza come unica degna condizione umana, la potenzialità lirica del rischio fisico… Mi chiedo, ma funzionano ancora così i diciottenni? Quella che era, in fondo, la turbolenza di una stagione fisiologica, l’irruenza dei giovani maschi, passibile di divenire sublime o efferata a seconda dei casi, è stata a sua volta estirpata? O trasformata in qualcosa di differente? E, manco a dirlo, di più meschino, basso e plebeo?
Come che sia… ripiombato a fine lettura nella mezza età, non ho potuto fare a meno di chiedermi come fosse possibile che l’incanto potesse ripetersi simile, se non identico, a distanza di decenni. La risposta che mi sono dato è che, al di là dell’ovvia potenza contenutistica, c’è uno Jünger per ogni stagione della vita. E sebbene nulla eguagli, a mio avviso, la fase “bellica” della sua opera, così poeticamente febbricitante, così liricamente muscolare, quasi da mondo omerico trasferito nell’era dell’industria pesante, c’è di che trarre insegnamenti preziosissimi ad ogni capitolo del suo lunghissimo periplo intellettuale.
Personalmente, attraverso le sue pagine riesco sempre a riconciliarmi con una parte di me con cui, spesso e volentieri, vengo alle mani: quella libertaria. In quelle pagine, infatti, acquisisce verosimiglianza una quota di umanità sufficientemente evoluta da comprendere che il concetto di libertà è qualcosa di radicalmente differente dalla semplice assenza di regole e autorità. Che il peso di queste ultime è inversamente proporzionale allo stadio di maturazione e consapevolezza cui sia riuscita a pervenire una comunità. Ne consegue che una condizione compiutamente civile dovrebbe poter fare a meno di larghissima parte delle regole e di qualsiasi forma di autorità costituita.
Un percorso che ci conduce direttamente all’Anarca tematizzato da Jünger in Eumeswil, cui avete dedicato uno straordinario pezzo nella Mano di Gloria…
 L’Anarca sottoscrive senz’altro tale aspirazione. Ma, constatato quanto sia a dir poco prematura, sceglie, piuttosto, di fare comunità a sé. Tuttavia, ci dice anche che quando un’autorità è palesemente degradata e dedita a un mortificante esproprio di dignità, risorse e possibilità di sussistenza civile ai cittadini, l’uomo libero non può esimersi dal passare all’azione. E qui entra in gioco il tema dell’ascesi bellica. A differenza di tanti illustri cialtroni suoi coevi, Jünger non trova la guerra né bella, né utile, né necessaria. I suoi toni non sono mai smaccatamente apologetici e non cadono nella trappola di una retorica propagandistica, tipica di chi non riuscì mai a togliere le gambe da sotto la scrivania. In compenso, al culmine di un’esperienza interiore commisurata all’immanità della tragedia riesce a scorgere, come in una serie di lampi accecanti, le conseguenze ultime di una – allora solo ipotetica – pace perenne. È una visione quasi oracolare che, considerando il nostro oggi, spaventa per precisione e chiaroveggenza.
L’Anarca sottoscrive senz’altro tale aspirazione. Ma, constatato quanto sia a dir poco prematura, sceglie, piuttosto, di fare comunità a sé. Tuttavia, ci dice anche che quando un’autorità è palesemente degradata e dedita a un mortificante esproprio di dignità, risorse e possibilità di sussistenza civile ai cittadini, l’uomo libero non può esimersi dal passare all’azione. E qui entra in gioco il tema dell’ascesi bellica. A differenza di tanti illustri cialtroni suoi coevi, Jünger non trova la guerra né bella, né utile, né necessaria. I suoi toni non sono mai smaccatamente apologetici e non cadono nella trappola di una retorica propagandistica, tipica di chi non riuscì mai a togliere le gambe da sotto la scrivania. In compenso, al culmine di un’esperienza interiore commisurata all’immanità della tragedia riesce a scorgere, come in una serie di lampi accecanti, le conseguenze ultime di una – allora solo ipotetica – pace perenne. È una visione quasi oracolare che, considerando il nostro oggi, spaventa per precisione e chiaroveggenza.
Uno dei sottaciuti problemi di noi contemporanei, che Jünger aveva previsto e sezionato a fondo, consiste esattamente in questo: nell’essere creature di un tempo di pace. Nati e divenuti adulti nel corso di una congiuntura storica probabilmente irripetibile, stentiamo a comprendere e oggettivare la deriva barbarica e predatoria sulla quale le attuali élite hanno dirottato il mondo. E ci scopriamo frustrati e impotenti, come è logico si senta chiunque abbia avuto la fortuna di consumare l’intera esistenza senza mai rischiare davvero. Senza mai un’occasione per conoscere se stesso fino in fondo, mettendosi alla prova una volta per tutte.
Quale aspetto del retaggio jüngeriano è preponderante nell’esperienza di IANVA?
È qualcosa di cui i contemporanei sono sempre pronti a farsi beffe sguaiate. Ossia l’esigenza, quasi fisica, di esprimere con la propria persona un senso di dignità e di distacco in mezzo alla volgarità e alla superficialità che imperversano.
Infrante o dimenticate le norme con cui una società può dare una disciplina all’individuo, venuta meno la sua autorevolezza stessa per produrne di nuove, cosa resta? Resta il dovere dell’individuo di costruirsi una dignità cavandola dal fondo di se stesso. Ed è difficile realizzare ciò senza qualche esagerazione, anche solo per difendersi dalla rilassatezza orgiastica da cui si è circondati. Occorre non abbandonarsi mai. Non accettare di galleggiare alla deriva nell’ambiente sociale. È una sorta d’istinto radicale che ti dice che esistere significa resistere, puntare i talloni a terra per non farsi portare via dalla corrente. E in un’epoca come la nostra, fatta solo di “correnti” e “cedimenti”, ai giovani farebbe senz’altro bene prendere qualche contatto, personale o librario, con uomini che non si fanno trascinare.
Dico, infine, che non è più tollerabile un ceto intellettuale che persista nell’inganno di ascrivere queste prassi di resistenza al campo del puro conservatorismo. Delle due l’una: o ci credono davvero, dichiarandosi con ciò integralmente stupidi, o sono nella più sfacciata malafede. Dovrebbe infatti risultare evidente come quelle che definiamo libertà pubbliche non siano, in fondo, che altrettante resistenze. È questa, credo, una delle migliori specificità europee: la riconversione a dinamismo di ciò che è statico. Lo “stato” di libertà risulta da una pluralità di forze che resistono le une alle altre. Le libertà contemporanee sono illusorie perché gabellano come oggettive quelle che sono astrazioni a buon mercato. Veri assoluti metafisici, irreali quanto la fede nei miracoli. Nella realtà concreta l’azione dinamica è divenuta esclusivo appannaggio di minoranze onnipotenti, con la massa sociale ridotta a uno stato di passività assoluta e, dunque, rassegnata a farsi trascinare ovunque piacerà a questi potenti. Resistere e sabotare, anche senza speranza, diventa dunque un dovere, un atto di rispetto che gli uomini liberi debbono a loro stessi.
Canone Europeo contiene una tirata contro il politically correct, anch’essa anticipata da quel «corretto pensare» evocato in L’Occidente…
L’intero progetto IANVA, in realtà, nasce all’insegna di un sentimento composito, ma per nulla ambiguo o sfuggente. In esso trovano posto il disprezzo per larga parte del sistema valoriale contemporaneo, il rifiuto di lasciarvi crescere un sentimento di cittadinanza “temporale” e la tentazione irresistibile di sfidare e sbeffeggiare tutto ciò che esso comprende o produce. Ovviamente c’è voluto un nulla per identificare i meccanismi, ormai puramente automatici, mediante i quali le voci critiche vengono azzerate con modico impegno. Nonché per comprendere che, di “rivolte” come la nostra, questo sistema è in grado di metabolizzarne a milioni. Senza peraltro poterci sottrarre all’impressione che, dopotutto, non stiamo che mimando e ritualizzando un surrogato dell’azione e della rivolta reali, ormai precluse forse per l’eternità. Non resta, dunque, che evocarle mediante una pantomima più o meno artistica, sebbene non galvanizzante come ai primi tempi. Allora avevi davvero l’impressione di fare una sorta di tiro a segno: ogni sparo, un centro. Ma, ammesso che tale percezione fosse tutta nelle nostre teste, resta forse meno giusto, meno doveroso continuare a mettersi di traverso?
Purtroppo, però, ci sono altre verità sulle quali non posso censurarmi. In primo luogo che, nella nostra esperienza, le peggiori carognate e i più infidi bastoni tra le ruote li dobbiamo unicamente a gente che, almeno sulla carta, vantava scorrettezze anche più veraci delle nostre. Forse non sarà questo il contesto ideale per ribadire certi fatti oggettivi, ma, al di là del consueto ostracismo, la sinistra politicamente corretta non ha mai bandito “crociate” contro di noi. Certi altri soggetti, ciancianti a vanvera di onore e fedeltà, sì. Secondariamente, si è andato precisando un parallelo e non meno redditizio business del politicamente scorretto.
Il conformismo dell’anticonformismo, come è stato definito…
Anch’esso ha i suoi campioni mediatici, divenuti ormai personaggi di primo piano nel mondo della comunicazione. Grazie a costoro la sacrosanta critica ad un sistema di pensiero dagli ormai evidenti intenti totalitari si è ridotta ad una sequela di stolide provocazioni al limite della gag di pessimo gusto. E ciò dovrebbe spiegare perché a questa gente, invece della denuncia penale, è toccata una parcellizzazione per il servizio svolto.
Infine, lo scenario di una massa di sudditi occidentali calpestati, ma imbelli in quanto paralizzati da un’autocensura all’insegna del politicamente corretto, è divenuto completamente inverosimile. Sta anzi iniziando ad assomigliare, consentimi, all’ennesima scusa che determinati ambienti “dissidenti” o “elitari” accordano a loro stessi. Un’assoluzione d’ufficio alla loro inconcludenza, al loro litigioso settarismo e all’immobilismo che nasce dall’inveterata abitudine alla vita comoda.
La gente – la chiamo così perché popolo è un termine che implica una dignità che i nostri contemporanei neppure si sognano – resta inerte per cause altrettanto degenerative, ma di ordine prevalentemente bio-antropologico. Con la sempiterna, fedele compagna di viaggio di sempre, la paura, come ingrediente principale. E non certo in virtù di un modello di correttezza politica al quale non crede più nessuno, salvo una risicata minoranza di conformisti leccaculi, neo-femministe isteroidi e qualche genuino imbecille. Li hai visti, certi giornalisti o “comunicatori” costretti a dire assessora o presidenta come da superiore diktat… come scappa da ridere avvelenato persino a loro! C’è da scommettere che, se mai dovesse arrivare il giorno della resa dei conti, questa tipologia umana, che mastica amaro ma si adegua a tutto, compreso il ridicolo, sarebbe la prima a cui si dovrebbe mettere un freno. Li vedremmo accalcarsi per prendere a sediate e pisciare addosso ai cadaveri che penzolano dai lampioni. Il che, come scenario ipotetico, aggiunge schifo allo schifo.
Ne La Mano Di Gloria, la rivolta contro il sistema vigente – il famigerato Combinat – è sempre accompagnata da un elemento trascendente. Che si manifesta ad esempio ne Le Stelle E I Falò, a mio parere il vostro pezzo più evocativo di sempre.
 Curioso e pure notevolmente interessante che tra i tanti momenti narrativi in cui una qualche forma di sacralità o trascendenza si affaccia, sia pure con varie sfumature di ritegno, tu abbia scelto proprio Le Stelle E I Falò. Ovvero una delle poche parti in cui il progressivo erigersi del corpus ideologico della Mano Di Gloria si esplica attraverso una narrazione e una percezione femminili. Ciò malgrado vi si descriva l’evocazione di un sentimento di fratellanza d’armi, dalle connotazioni decisamente arcaiche e sacrali, mediante un rituale di esclusiva pertinenza maschile. Nel corso del quale, al cospetto delle forze primarie della natura, si sancisce la sacralità di un vincolo di cameratismo che, proprio perché dovrà vedersela con un nemico la cui natura maligna è altrettanto connotata metafisicamente, non potrà che sciogliersi negli elementi stessi. Post-mortem e giammai prima, come poi effettivamente sarà. Ma la vera chiave di lettura, come dicevo, consiste nel fatto che il punto di vista attraverso cui prendiamo atto dell’effettiva sacralità della scena è quello della protagonista femminile, la quale assiste come spettatrice. Mentre la comunità dei futuri combattenti si galvanizza con un chiassoso rituale collettivo non del tutto esente da goliardia e spirito di branco, è il lento dispiegarsi del monologo interiore della donna, da principio in bilico tra la critica e l’indulgenza, che alla fine ci conduce, quasi con dolcezza, al regno della trascendenza e del perenne. Non a caso, infatti, questo passaggio narrativo si rivelerà come il primo, serio punto di non ritorno per i nostri ribelli. Chiamato a testimone del loro agire, l’Eterno risponde e li prende in parola: da lì in avanti ogni ripensamento sarà impossibile.
Curioso e pure notevolmente interessante che tra i tanti momenti narrativi in cui una qualche forma di sacralità o trascendenza si affaccia, sia pure con varie sfumature di ritegno, tu abbia scelto proprio Le Stelle E I Falò. Ovvero una delle poche parti in cui il progressivo erigersi del corpus ideologico della Mano Di Gloria si esplica attraverso una narrazione e una percezione femminili. Ciò malgrado vi si descriva l’evocazione di un sentimento di fratellanza d’armi, dalle connotazioni decisamente arcaiche e sacrali, mediante un rituale di esclusiva pertinenza maschile. Nel corso del quale, al cospetto delle forze primarie della natura, si sancisce la sacralità di un vincolo di cameratismo che, proprio perché dovrà vedersela con un nemico la cui natura maligna è altrettanto connotata metafisicamente, non potrà che sciogliersi negli elementi stessi. Post-mortem e giammai prima, come poi effettivamente sarà. Ma la vera chiave di lettura, come dicevo, consiste nel fatto che il punto di vista attraverso cui prendiamo atto dell’effettiva sacralità della scena è quello della protagonista femminile, la quale assiste come spettatrice. Mentre la comunità dei futuri combattenti si galvanizza con un chiassoso rituale collettivo non del tutto esente da goliardia e spirito di branco, è il lento dispiegarsi del monologo interiore della donna, da principio in bilico tra la critica e l’indulgenza, che alla fine ci conduce, quasi con dolcezza, al regno della trascendenza e del perenne. Non a caso, infatti, questo passaggio narrativo si rivelerà come il primo, serio punto di non ritorno per i nostri ribelli. Chiamato a testimone del loro agire, l’Eterno risponde e li prende in parola: da lì in avanti ogni ripensamento sarà impossibile.
Al di là delle ovvie esigenze narrative, non ho difficoltà ad ammettere che imputo all’ormai più che radicato materialismo di massa, e al sostanziale ateismo collettivo che ne è logica conseguenza, quella prodigiosa vigliaccheria che è il vero tratto saliente dell’Occidente contemporaneo. I nostri illuministi da circolo del tennis dovrebbero iniziare a riflettere sul fatto che forse non è stato un grande affare esserci liberati dal Timor Dei. Il Dio punitivo, che frustrava i nostri sani istinti e sacrosanti appetiti, disgraziatamente, era anche quello che, al momento delle prove più dure, potevamo ritrovarci al nostro fianco. Che fosse vero o meno, francamente, è un problema che mi pare superato. L’essenziale è che, per mettersi a rischio fino in fondo, è necessario “percepire” una qualche presenza a monte di noi, non fosse altro che quella di un’idea, una causa che s’innalza fino ad assomigliare ad una stella fissa. L’intima certezza, condivisa da ogni contemporaneo, che tutto inizi e termini con la propria personale sussistenza fisica è, di per sé, l’annientamento di ogni scelta che comporti l’assunzione di un rischio.
Luisa Ferida, Benvenuto Cellini, Vincenzo Peruggia, Pier Paolo Pasolini… Il vostro è un interrogare la storia che attraversa personaggi eccentrici, spesso dimenticati o “ortopedizzati”. Quale sapienza può trarre il canone da costoro?
Per esempio, che può bastare la consapevolezza di un solo istante per incarnare, con superba aderenza, un modello esistenziale ben più alto di quello in cui la nostra natura ci avrebbe teoricamente confinato.
Atteniamoci, a titolo di esempio, ai quattro personaggi che hai citato. C’è un aspetto che li accomuna tutti: l’essere stati ritenuti a vario titolo “immorali” dall’opinione corrente del loro tempo. Compreso il povero Peruggia, colpito da un duplice pregiudizio: quello verso le classi subalterne e quello verso gli immigrati. Il villain ideale, se fosse balzato in cronaca per via d’un cruento delitto per ragioni abiette, ma oltremodo deludente in veste di unico ideatore ed esecutore del “furto del secolo”. Ma è proprio in virtù di tale ottusa pregiudiziale pubblica che quest’uomo, semplice fino all’ingenuità, si ritrova a giganteggiare. Ciò, peraltro, mette a fuoco un’ulteriore analogia: a vario titolo, con differenti gradi di obiettività (e altrettanto variegate declinazioni di narcisismo) tutte queste personalità si percepiscono profondamente artistiche. Persino Peruggia si definisce “pittore di muri” in luogo di imbianchino.
Consideriamo la prontezza con cui sa profittare di una circostanza irripetibile. La sua confusa, ma sinceramente disinteressata rivendicazione patriottica… Dettagli che rivelano una consapevolezza profonda delle implicazioni “comunicative” della sua azione. Quando sottrae La Gioconda, non agisce né per lucro, né per fama. E, forse, neppure per vendetta. Si direbbe piuttosto che intenda apporre una sorta di sfregio sul consueto accomodamento storico che assegna alla Patria il ruolo millenario di ancella vessata. E per se stesso rivendica, semmai, l’unicità di un atto che, solo, basta a dare senso a una vita.
Mi pare, correggimi se sbaglio, la variante istintiva, popolana e “illetterata” della classica sprezzatura dannunziana. Tra Peruggia e Perasso, detto Balilla, che inizia un’insurrezione da solo e a forza di sassate, non c’è poi quella gran differenza. Li trovo sintonizzati con un dimenticato risvolto della psiche nazionale: quello che faceva sì che, al momento decisivo, l’italiano sapesse sorprenderti sempre.
Da noi non sono mai stati rari atti di eroismo inattesi, di nobiltà quasi regale, da parte di soggetti meno che umili. Così come si sono visti atti di viltà e meschinità assai meno che plebee da parte di Re. Né sono mancate vere principesse le cui condotte sarebbero state degne d’un postribolo e contegni all’insegna della più alta e serena nobiltà da parte di donne che, agli occhi del mondo, apparivano certo più vicine alla categoria delle sgualdrine che non a quella delle principesse.
Che poi è il caso di Luisa Ferida.
 Attrice dotata d’indubbio talento, ma che fa carriera grazie soprattutto alla bellezza. E anche a una certa, diciamo, disinvoltura nel farvi occasionale ricorso (cose che comunque, se confrontate con quelle considerate normali oggi, sono letteratura per educande). Della vicenda della Ferida l’aspetto che fa oggettivamente rabbia non è tanto che si decida di ucciderla comunque, quando è ormai evidente la sua assoluta estraneità ai fatti che le vengono contestati. Quanto piuttosto che la sua riabilitazione postuma venga ancora oggi puntualmente affossata dalle pressioni di una certa parte politica. È storia recente, credo, la rimozione d’autorità della targa commemorativa posta sul luogo dove, incinta di sei mesi, venne trucidata. Sfido io: la revisione del caso implicherebbe l’ammissione che almeno un paio di illustri “Padri della Rebubblica”, la cui memoria è intoccabile al limite della canonizzazione laica, ordinarono in perfetta e consapevole lucidità il deliberato assassinio di una gestante del tutto innocente. E questo in virtù di una sorta di furore iconoclastico che decretava morte per la sola colpa di aver incarnato un volto “seducente” del regime. Non ha nulla da ridire, in questo caso, il gineceo sinistrato, tutto neolingua e femminicidio?
Attrice dotata d’indubbio talento, ma che fa carriera grazie soprattutto alla bellezza. E anche a una certa, diciamo, disinvoltura nel farvi occasionale ricorso (cose che comunque, se confrontate con quelle considerate normali oggi, sono letteratura per educande). Della vicenda della Ferida l’aspetto che fa oggettivamente rabbia non è tanto che si decida di ucciderla comunque, quando è ormai evidente la sua assoluta estraneità ai fatti che le vengono contestati. Quanto piuttosto che la sua riabilitazione postuma venga ancora oggi puntualmente affossata dalle pressioni di una certa parte politica. È storia recente, credo, la rimozione d’autorità della targa commemorativa posta sul luogo dove, incinta di sei mesi, venne trucidata. Sfido io: la revisione del caso implicherebbe l’ammissione che almeno un paio di illustri “Padri della Rebubblica”, la cui memoria è intoccabile al limite della canonizzazione laica, ordinarono in perfetta e consapevole lucidità il deliberato assassinio di una gestante del tutto innocente. E questo in virtù di una sorta di furore iconoclastico che decretava morte per la sola colpa di aver incarnato un volto “seducente” del regime. Non ha nulla da ridire, in questo caso, il gineceo sinistrato, tutto neolingua e femminicidio?
Una simile bassezza morale e una siffatta faziosità, bellamente sconfinate nella logica criminale, non fanno che rendere monumentale la figura di una donna in fondo come tante. Ma che decide di morire con la fierezza e dignità che tante volte, nei panni dell’indomita eroina, aveva solo recitato sullo schermo. Chi può sapere cosa passa per la testa in simili frangenti? Quale superiore destino si spera di afferrare? A chi si pensa debbano giovare esempi del genere? Eppure, piaccia o no, sono atti capaci d’infliggere cicatrici pubbliche che il tempo fatica a cancellare. E chi lavora incessantemente alla causa della “riduzione” umana lo sa molto bene. Come, per esempio, tutti quei soggetti arruolati di recente alla causa di riguadagnare “a sinistra” la memoria di Pasolini.
Un’operazione piuttosto paradossale, in effetti…
Pasolini non si è mai collocato a Destra da vivo né, tanto meno, sarebbe logico collocarvelo da morto. Non fosse altro perché è ormai risaputo che la manovalanza che si fece carico della sua esecuzione era stata reclutata proprio in quella “terra di mezzo” tra neofascismo e criminalità organizzata, con l’abituale e “discreta” supervisione dei soliti Servizi. E comunque la Destra di quel tempo non si sognò neppure lontanamente di produrre una lettura dei fatti differente da quella corrente: l’epilogo caparbiamente ricercato e pienamente meritato di una vita malvissuta. C’è purtroppo del vero: certe condotte comportano rischi molto seri.
Ma il fatto che un’esca si sia dimostrata funzionale per via della discutibile routine privata del soggetto-bersaglio non rende meno verosimile l’ipotesi dell’agguato. Anzi, semmai la rafforza e non smuove di un millimetro le implicazioni, ben più sudice, a cui immediatamente conduce il vetusto, ma immarcescibile quesito: cui prodest?
Al tempo dei fatti, Pasolini è ancora una figura di grande carisma e autorevolezza, ma in procinto di esaurire i propri “crediti” presso gli ambienti che contano. E non certo per le consuete accuse d’immoralità, sebbene la sanzione dell’espulsione dal Partito fosse da tempo arrivata. Ma, al saldo di ciò, è tutt’altro che un isolato. Dispone di una rubrica, esente da censura, sulla prima pagina del maggiore quotidiano italiano. I suoi film trovano sempre e comunque dei finanziatori di altissimo livello. Viene regolarmente intervistato non solo dalla televisione italiana, ma anche da gran parte di quelle europee. Vede regolarmente pubblicato ogni suo scritto e può contare su un pubblico, minoritario certo, ma ben fidelizzato e ancor meglio selezionato.
Sennonché, a un certo punto, qualcosa sembra cambiare.
Pasolini inizia ad avvertire l’aria farsi pesante attorno a lui. Questo non lo dicono i “complottisti”, ma lui stesso. E lo ribadisce a pochi giorni dalla morte sulla TV di Stato francese: le cose stanno ben diversamente da quanto la gente, anche la più attenta e responsabile, possa immaginare. Di quanto lui stesso sarebbe stato disposto a credere solo fino a qualche tempo prima.
In quei giorni è al lavoro su Petrolio, il romanzo a chiave che non finirà mai e che avrebbe dovuto rivelare ciò a cui era pervenuto. Si parla, molto probabilmente, dell’entità occulta che, dalla fine degli anni Cinquanta in avanti, ha sempre tenuto questo paese sotto un vero “tallone di ferro”. Previo, per altri versi, assecondarne e incoraggiarne le derive antropologiche e lo scivolamento verso la barbarie socio-culturale, come del resto lo stesso Pasolini denuncia nei suoi ultimi scritti. Una “Superstruttura” che al solo sfiorarla, nell’Italia democratica, si finisce sempre prontamente a concimare la terra. Dunque, l’intellettuale comunista e benestante che, nottetempo, rimorchia ragazzi sottoproletari in cerca di un facile guadagno è allo stesso tempo un uomo che sa sfoderare un coraggio che è appannaggio di pochi. Vogliamo chiamarli con il loro nome, per quanto sia fuori moda? Eroi.
Nulla, neppure il crescente silenzio in cui cadono le sue requisitorie e la progressiva rarefazione di nomi illustri disposti a fiancheggiarlo, neppure le minacce, prima velate e poi palesi, lo dissuadono. Ha visto la battaglia e non riesce più a distoglierne lo sguardo. Non vi rinuncerebbe per nulla al mondo. Perché non può: fa parte di quella minoranza d’italiani che la sfida ce l’ha nel sangue.
Ed è una sfida epocale, la sua…
Pasolini ha intravisto i reali contorni del Male che attanaglia questo paese. Ha intuito le abissali profondità delle quali necessita l’immane porzione sommersa dell’iceberg per restare occultata… E, solo, decide di scendere in campo. Nella piena consapevolezza della letalità del rischio.
 Per tali ragioni, la sua recente trasformazione in illustre caduto sul campo della causa gender, esattamente il repertorio di sotto-ideologie flaccide, petulanti e neoborghesucce che Pasolini avrebbe disprezzato a morte, mi pare risponda ad una logica losca quasi quanto quella che ne decretò la morte. In altri termini: la stessa gente che combatte la prostituzione denunciando, sanzionando e mettendo alla gogna unicamente il cliente, sull’altro versante trova eroico e fondativo finire ammazzati di botte andando a marchettari… Un Pasolini del genere credo debbano trovarlo ben più funzionale, corretto e spendibile di quell’altro: quello che muore nel coraggioso tentativo di denunciare e sventare un complotto anti-nazionale. E che proprio per tale ragione è finito per guadagnare rispetto nel campo opposto. Come riammetterlo dunque nel Pleroma delle anime candide e delle cause belle dopo decenni trascorsi a spasso tra le tesi di quei lumpen dei complottisti destroidi? Semplice: negando a oltranza l’esistenza di un complotto e l’intenzione di Pasolini di sventarlo a costo della vita. E cercando di ricondurre il tutto ai soli territori congeniali alla sinistra contemporanea: la politica di genere, l’attenzione per le minoranze, eccetera eccetera. E che importa se nelle requisitorie dei suoi ultimi mesi Pasolini parla di tutt’altro e mostra di accordare alla suddetta problematica un’attenzione e un’importanza pressoché nulle! Come di consueto scatta la riscrizione dei fatti, ma, intanto, l’esempio di un coraggio pressoché estinto nell’Italia contemporanea resta lì, a campeggiare con un’evidenza ancora una volta statuaria.
Per tali ragioni, la sua recente trasformazione in illustre caduto sul campo della causa gender, esattamente il repertorio di sotto-ideologie flaccide, petulanti e neoborghesucce che Pasolini avrebbe disprezzato a morte, mi pare risponda ad una logica losca quasi quanto quella che ne decretò la morte. In altri termini: la stessa gente che combatte la prostituzione denunciando, sanzionando e mettendo alla gogna unicamente il cliente, sull’altro versante trova eroico e fondativo finire ammazzati di botte andando a marchettari… Un Pasolini del genere credo debbano trovarlo ben più funzionale, corretto e spendibile di quell’altro: quello che muore nel coraggioso tentativo di denunciare e sventare un complotto anti-nazionale. E che proprio per tale ragione è finito per guadagnare rispetto nel campo opposto. Come riammetterlo dunque nel Pleroma delle anime candide e delle cause belle dopo decenni trascorsi a spasso tra le tesi di quei lumpen dei complottisti destroidi? Semplice: negando a oltranza l’esistenza di un complotto e l’intenzione di Pasolini di sventarlo a costo della vita. E cercando di ricondurre il tutto ai soli territori congeniali alla sinistra contemporanea: la politica di genere, l’attenzione per le minoranze, eccetera eccetera. E che importa se nelle requisitorie dei suoi ultimi mesi Pasolini parla di tutt’altro e mostra di accordare alla suddetta problematica un’attenzione e un’importanza pressoché nulle! Come di consueto scatta la riscrizione dei fatti, ma, intanto, l’esempio di un coraggio pressoché estinto nell’Italia contemporanea resta lì, a campeggiare con un’evidenza ancora una volta statuaria.
C’è invece chi un monumento pensò bene di erigerselo da sé, ancora in vita, giusto per portarsi avanti col lavoro: gli alloggi dell’immortalità non si approntano in cinque minuti. E non si parla di D’Annunzio, che con la sua ultima residenza terrena si fece costruire al contempo un monumento e un mausoleo, bensì di Cellini.
Cui è dedicata, appunto, una traccia del Canone.
Benvenuto Cellini non ebbe a toccare una sola pietra per edificare il proprio. Infatti, quel monumento, che sfida i secoli, è costruito unicamente di parole. Il che è abbastanza strano se si considera che proprio su un’abilità manuale virtuosa oltre ogni limite egli doveva la meritata fama da vivente. Da genuino ammiratore del Cellini artista, sulle prime, provavo un certo fastidio all’idea che gran parte della sua fama postuma fosse dovuta a un’autobiografia. Nella quale, oltretutto, iperboli e spacconate non sono certo dosate col contagocce. Ma, una volta entrato nello spirito di quel libro straordinario, ne ho concluso che sono proprio queste ultime a connotare definitivamente l’uomo e l’artista, quasi quanto il suo stile, unico quando si tratti di trasformare la materia. Cellini è il prototipo e, al contempo, il più completo e dotato rappresentante di una tipologia umana tutta italiana della quale D’Annunzio è solo il più noto e pirotecnico degli eredi. Ma anche lo stesso Guillet, che artista non era, o un Mario Schifano, che artista lo era “solo”, senza eroismi concreti o vagheggiati, non si distanziano di molto. E neppure un Malaparte, se è per questo.
Tra i ranghi di un popolo che deve il corredo genetico massimalmente a schiavi e liberti levantini, le posture interiori a servi della gleba e a pingui e pavidi mercanti, l’attitudine delle sue intelligenze all’untuoso paternalismo e conformismo dei chierici, le costumanze dei suoi notabilati all’opportunismo e alla doppiezza dei cortigiani, è purtuttavia sempre esistita una minoranza in grado di ardire ed osare in vece del resto del gregge. Ma è soprattutto grazie a certi “ingestibili” connazionali se, sul piano dell’esattezza estetica (intesa nel suo senso etimologico, cioè conoscenza del mondo sensibile), noi si è sempre riusciti ad essere un passo avanti a tutti. Del quadro, ovviamente, fa parte anche una certa estetizzazione del pensiero e della politica che decenni di mediocrità e grigiore istituzionali non sono riusciti ad estirpare del tutto dalla sfera percettiva nazionale. Questo, forse, potrà far inorridire i nostrani democrat che passano la vita a studiare da anglosassoni, ma è proprio dalle vicende chiaroscurali, dall’oscillazione quasi schizofrenica tra dannazione e salvezza, abnegazione sublime e delirante narcisismo, che sono sempre scaturite le nostre pagine storiche meno disonorevoli. Nonché le nostre più imitate ricette artistiche ed esistenziali.
In tal senso Cellini, persino più di D’Annunzio, risulta la facies stessa dell’artista che imprime ogni manieristico prestigio alla propria vita almeno quanto alla propria opera. E se ciò deve comportare spericolato attivismo anche nelle vicende pubbliche del tempo in corso, che non ci si tiri indietro, mai. Del resto, loro c’insegnano, la vita non è mai troppo preziosa finché esisterà qualcosa di abbastanza grande e degno per giocarsela in perfetta serenità d’animo.
Ciò chiarisce il senso finale e, al contempo, risponde alla tua domanda iniziale. Esiste, compreso all’interno del Canone, anche un piccolo Canone Italiano. È quello che tutti questi personaggi hanno incarnato con naturalezza, anche al di là della loro consapevolezza. Lo stesso che fa dire a Pietro Jorio, nel Manifesto della Mano Di Gloria, come primo assunto: «Non ribellarti perché è giusto. Fallo perché è bello».
Oggi il Canone si manifesta nella sua assenza, ex negativo, fardello e ipoteca. È il convitato di pietra del nostro tempo, posto sotto la ridicola quanto puerile insegna dell’aggiornamento. Si modernizza Shakespeare, si rinnega Dante, si sente il bisogno di “riscrivere”, “rendere fruibile”, “divulgare”…
È opportuno non perdere mai di vista un dato a monte: oggi esiste unicamente la comunicazione. L’informazione, o sedicente tale, è solo una sua declinazione parziale, ma altrettanto onnipresente. La Cultura, nell’accezione enfatica con cui siamo abituati a pensarla, è al contrario un processo lungo. Questa differente temporalità ne attesta la diversità di natura. Un sapere necessita di maturazione, il che implica strutture temporalmente stabili, che tuttavia sono in via di rimozione, perché l’efficienza e la produttività che anche l’industria culturale deve assicurare necessitano solo di simultaneità.
È questo il primo dei problemi: la velocizzazione dei dati finisce per far proliferare l’Uniformità. Da qui è probabile si dipartano i mutamenti patologici che infestano il corpo sociale. Il secondo dei problemi è che questa proliferazione dell’uguale è percepita come una crescita. Ma siccome la crescita illimitata, al di fuori del dogma ideologico imperante, è incompatibile con la realtà fisica, lo stesso vale anche per la moltiplicazione cancerosa di dati univoci. In tal modo la produzione diventa facilmente distruzione, l’informazione deformazione e la comunicazione accumulo. Questa uniformità è altresì informe: deficitando di ogni seria tensione dialettica, finisce per fornire un modulo di vicinanza indifferente, un’insipida unitarietà al ribasso tendente all’indifferenziato.
E qui giungiamo al nucleo del problema: il modello moltiplicativo dell’univoco sta investendo non solo la Cultura propriamente detta, ma anche ogni ambito vitale. Così, se da un lato si accumulano amici e follower senza mai incontrare veramente l’Altro da sé, dall’altro si ammassano informazioni e dati senza mai giungere a un sapere. In tale sciagurato contesto, gli aggiornamenti culturali veri o presunti che, periodicamente, qualcuno si fa dovere di propinarci sono solo uno dei tanti sintomi della malattia, non la malattia in se stessa.
Non è triste più di tanto il fatto che Dante venga letto e commentato sulla TV di Stato in prima serata da un comico. Piuttosto è un comico di regime ad essere triste, mentre Dante resta assiso dov’è. Né credo mi disturberebbe se un giorno qualcuno commercializzasse un’escursione nella realtà virtuale dell’Inferno di Dante, o nella Firenze dei Medici o nel bel mezzo della battaglia di Poitiers… Il grave sarebbe la disposizione mentale con cui, presumibilmente, ci si accosterebbe a simili esperienze. Lo studente contemporaneo che scandaglia la Rete alla ricerca della nozione storica che possa fargli superare il prossimo test lo fa con lo stesso spirito con il quale fruisce del gossip e delle news. In tutti i casi non si pone alcun problema circa l’attendibilità delle fonti e l’aderenza ai fatti, e soprattutto rifugge istintivamente ogni problematica e, dunque, ogni seria riflessione. Da qui a parificare idealmente anche la rilevanza del dato storico con quella del più deperibile pettegolezzo il passo è brevissimo. Dunque, possono benissimo trasformare lo studio della Storia in un videogame, ma alla fine il percepito non riguarderà la Storia, ma il game. Se questo è il progresso, sono ben felice di avere due terzi della vita alle spalle.
Da ultimo, lasciami brevissimamente manifestare tutto il disprezzo di cui sono capace per quei coetanei, magari anche insegnanti, che pur di non sentirsi invecchiati e superati s’ingegnano a scovare sempre nuovi argomenti per recare acqua al mulino del possibilismo: si vergognassero! E non dico altro.
Una delle tracce del vostro ultimo lavoro, L’Alba Delle Ceneri, è dedicata ai testimoni di un altro Novecento, ben lungi da quello cantato dagli aedi del progressismo. Una sequela di visioni del mondo che originò una galleria di suicidi, una schiera di titani incapaci, per così dire, di metabolizzare (e come avrebbero potuto, d’altronde?) il collasso di una civiltà.
 Quand’è che ci si trova a vivere una proverbiale Età dell’Oro? Da quali indizi dovremmo dedurre che i giorni che stiamo vivendo saranno ricordati in futuro come una stagione di grazia irripetibile? O, per meglio inquadrare la questione, quante fasi ascendenti, culmini, discese ed eclissi ha finora conosciuto la civiltà alla quale, quantunque sempre meno degnamente, apparteniamo? Pencolanti tra la tetraggine e la multicolorata stupidità dell’era globale, noi ex giovani troviamo oggi naturale, per esempio, condividere il ricordo degli anni Ottanta in forma di paradiso perduto. Seppur nella perfetta e razionalissima consapevolezza che la realtà di allora fosse, come in qualsiasi altra epoca, tutt’altro che paradisiaca. Ma è anche vero che c’era questa sorta di “spirito aereo” sottilmente euforizzante, questo vitalismo estetizzante tanto diffuso quanto a buon mercato. In realtà, come tutte le micro-fasi, anche questa piccola età dell’oro era per lo più confinata nella coscienza collettiva. Ed è curioso come, su scala minore, riproducesse tutte le configurazioni psichiche peculiari di altre e ben più fondate fasi “culminali”. Quali sono dunque questi indizi psichici? In primis direi la sensazione, del tutto irragionevole, che possa durare per sempre. Esattamente come la fugace magia di un innamoramento: non si riesce a scorgere alcuna ragione per cui debba finire, pur nella piena coscienza dell’illusorietà.
Quand’è che ci si trova a vivere una proverbiale Età dell’Oro? Da quali indizi dovremmo dedurre che i giorni che stiamo vivendo saranno ricordati in futuro come una stagione di grazia irripetibile? O, per meglio inquadrare la questione, quante fasi ascendenti, culmini, discese ed eclissi ha finora conosciuto la civiltà alla quale, quantunque sempre meno degnamente, apparteniamo? Pencolanti tra la tetraggine e la multicolorata stupidità dell’era globale, noi ex giovani troviamo oggi naturale, per esempio, condividere il ricordo degli anni Ottanta in forma di paradiso perduto. Seppur nella perfetta e razionalissima consapevolezza che la realtà di allora fosse, come in qualsiasi altra epoca, tutt’altro che paradisiaca. Ma è anche vero che c’era questa sorta di “spirito aereo” sottilmente euforizzante, questo vitalismo estetizzante tanto diffuso quanto a buon mercato. In realtà, come tutte le micro-fasi, anche questa piccola età dell’oro era per lo più confinata nella coscienza collettiva. Ed è curioso come, su scala minore, riproducesse tutte le configurazioni psichiche peculiari di altre e ben più fondate fasi “culminali”. Quali sono dunque questi indizi psichici? In primis direi la sensazione, del tutto irragionevole, che possa durare per sempre. Esattamente come la fugace magia di un innamoramento: non si riesce a scorgere alcuna ragione per cui debba finire, pur nella piena coscienza dell’illusorietà.
Ecco come, con ben altra pregnanza e concretezza, doveva percepirsi il culmine della Belle Époque, al tempo dell’Esposizione Internazionale di Parigi. O come si narrava il maturo Settecento dove, nell’apparentemente immutabile ordinamento dell’Ancien Régime, andava rapidamente maturando l’apocalisse rivoluzionaria. O, ancora, nella fase compiuta del Rinascimento, qual era lo spirito con cui si confrontava l’inesorabile logica temporale? Scomoderei ancora il nostro Benvenuto Cellini. Attraverso le sue pagine e quelle di tanti suoi contemporanei, la prima sensazione che si ricava è di una fruttifera pienezza. Cellini, come altri “intellettuali d’azione” suoi coevi, è un perfetto rappresentante antropologico del “miracolo rinascimentale”: poliedrico, eclettico, completo.
È come se su di loro si sia fermato per un attimo il cammino della civiltà, giunta a uno dei suoi apici. Da questa vetta essi poterono contemplare il passato con superiorità e scrutare all’avvenire con tristezza. Prima di questi gentiluomini c’era il soldataccio aduso all’ascia. Dopo, il cicisbeo. Queste esasperazioni, altrettanto peculiarmente “occidentali”, trovano in certe figure tardo-rinascimentali un’irripetibile sintesi armonica. Si osservi per esempio come, in Italia, dalla rude vitalità dell’Aretino si passi attraverso Baldassarre Castiglione all’Arcadia fronzoluta e inerte. E come, di per contro, in Inghilterra basti un Shakespeare per plasmare in materia di fuoco un suo Rinascimento, imprimendo alle opere la maschia impronta del genio.
Arte, pensiero, guerre, rivoluzioni, scandali, sciagure, atti d’eroismo e di viltà, dispute religiose sono il tessuto. Ma in questo tessuto sono ricamati i vizi e le virtù, i piaceri e i sacrifici. L’Umanità si divide in nobile e vile. Quella vile è come se non esistesse. Quella nobile può essere grande o meschina, ma è comunque protagonista. Gli uomini sono soldati e cortigiani insieme: dall’equilibrio tra questi due modi di vivere risulta la loro perfezione. Angusto? Forse… Eppure, da mondi come questi, apparentemente poveri di sfumature, la civiltà occidentale ha invariabilmente ricavato i suoi tesori, in termini di genio e bellezza. Di per contro, le lunghe fasi depressive hanno a loro volta prodotto adeguati cantori. Umberto Eco chiosava: «E l’Occidente che fa? Tramonta? Beh, dopotutto è il suo mestiere…». Sarà pure una gag, ma definisce un bel pezzo di verità. Al di là del dato geofisico, la storia dimostra una sorta di vocazione prettamente occidentale a vivere un’anticipazione di declino ed eclisse attraverso tormentate vicende culturali.
Giungiamo così al secolo su cui si sono appena chiusi i battenti…
È abbastanza evidente che la più traumatica e, probabilmente, definitiva delle crisi occidentali, della doppia apocalisse mondiale, abbia ingenerato la più vasta fioritura di cultura funerea a memoria d’uomo. E in ciò consiste, a mio avviso, il più sconcertante dei paradossi: la capacità di produrre una stagione “apicale” anche nella cultura della dissoluzione. In altri termini, c’è stata un’età dell’oro, una perfezione formale, anche nella poetica della fine.
Il suicidio, sebbene consegua quasi sempre da stati di seria patologia mentale, è altresì un marcatore assolutamente significativo laddove la sua rilevanza statistica si densifichi repentinamente nel mondo delle lettere e delle arti. Sotto questo profilo specifico, la congiuntura Occidente-Novecento offre uno scenario d’incomparabile tregenda. Con l’inevitabile riflesso esercitato su mondi intellettuali solo parzialmente occidentali come quello russo, con tutta la lunga teoria degli auto-depennati, per usare una terminologia dalle debite consonanze burocratiche, da Majakovskij a Marina Cvetaeva. O a quelli extra-europei, come nel caso di Mishima. È interessante notare come anche la propaggine statunitense non sfugga alla grande ombra, sebbene i suoi rappresentanti appartengano all’unica declinazione di civiltà uscita vincente da un conflitto durato quasi un secolo. Anzi, è specialmente nel primo e nel secondo dopoguerra che, in differita rispetto al vecchio continente, negli USA si registra la vera ecatombe. Infine, non trascurerei come anche nei ranghi di coloro che hanno esercitato forme espressive di più recente definizione, vedi la musica rock, i suicidi spesseggino tra le figure di più sicuro istinto letterario, da Nick Drake a Ian Curtis, fino a Rozz Williams e all’infelice Adrian Borland – con la debita eccezione del povero Kurt Cobain, dal lessico povero al limite dell’autismo.
Credo si trattasse degli ultimi fuochi (fatui) di cultura novecentesca, o meglio delle ultime possessioni da parte del suo cattivo genio dell’aria. Sarebbe auspicabile che qualcuno dotato delle competenze necessarie azzardasse prima o poi uno studio esteso e, possibilmente, comparato di questo fenomeno. Per quanto basilare, lo stranoto e recentemente ristampato Il Dio Selvaggio di Alfred Alvarez patisce oggi il limite di partire da molto lontano, dall’antichità classica, salvo arrestarsi, dopo un’avanzata a lunghi balzi, all’epoca in cui venne pubblicato, ossia i primi anni Sessanta. Con particolare riferimento alla morte della povera Sylvia Plath, buona amica dell’autore, il quale, presumibilmente, si decise ad affrontare un tema tanto temibile anche per gestire il dolore di questa perdita.
Nel booklet si trovano riferimenti al libro Tutto il ferro della torre Eiffel di Michele Mari, fonte bibliografica de L’Alba Delle Ceneri.
 Uno stravagante oggetto letterario la cui figura centrale è Walter Benjamin: le sue ossessioni culturali da esule e fuggiasco forniscono il materiale per imbastire una sorta di thriller simbolista, a sua volta pretesto per un funambolico esercizio di citazionismo erudito. Il Passage immaginario, corrispettivo nel mondo dei trapassati di quello céliniano, fin troppo traboccante vitali afrori, Mari lo intitola a una figura non certo novecentesca. Quel Jan Potocki cui anch’io non ho potuto che confermare l’accesso al funebre empireo. Le modalità con cui mette in pratica l’atto suicida, a metà tra l’artifizio barocco e lo shockadvertising contemporaneo e al limite malinconico di una vita non meno virtuosisticamente spericolata, lo rendono infatti una sorta di bizzarro protonovecentesco ad honorem. In questo passage, assomigliante piuttosto alla galleria fiocamente illuminata di un vecchio cimitero monumentale, Mari non colloca solo i suicidi che sono stati, ma anche quelli che saranno. Al punto che ci si chiede se Benjamin non sia a un passo dall’incontrare il se stesso che ha già consumato il proprio destino.
Uno stravagante oggetto letterario la cui figura centrale è Walter Benjamin: le sue ossessioni culturali da esule e fuggiasco forniscono il materiale per imbastire una sorta di thriller simbolista, a sua volta pretesto per un funambolico esercizio di citazionismo erudito. Il Passage immaginario, corrispettivo nel mondo dei trapassati di quello céliniano, fin troppo traboccante vitali afrori, Mari lo intitola a una figura non certo novecentesca. Quel Jan Potocki cui anch’io non ho potuto che confermare l’accesso al funebre empireo. Le modalità con cui mette in pratica l’atto suicida, a metà tra l’artifizio barocco e lo shockadvertising contemporaneo e al limite malinconico di una vita non meno virtuosisticamente spericolata, lo rendono infatti una sorta di bizzarro protonovecentesco ad honorem. In questo passage, assomigliante piuttosto alla galleria fiocamente illuminata di un vecchio cimitero monumentale, Mari non colloca solo i suicidi che sono stati, ma anche quelli che saranno. Al punto che ci si chiede se Benjamin non sia a un passo dall’incontrare il se stesso che ha già consumato il proprio destino.
Io mi sono divertito, si fa per dire, a estendere il gioco della citazione a campi estranei a quelli delle letteratura “alta” e spesso ho fornito l’indizio senza citare per nome il personaggio in questione. Ho voluto trasporre, per quanto possibile e con il dovuto rispetto, tutta la questione a una dimensione in qualche modo pop. Senza la pretesa di gabellare tale operazione per chissà quale chiave di lettura alternativa. E, magari, suggerendo qualche ulteriore domanda, tipo: che genere di apice stiamo vivendo oggi? Dopo quello della tragedia, forse quello della farsa? A giudicare dalla statura di certi personaggi considerati autorevoli non pare neppure così improbabile, come ipotesi.
Per concludere questa lunga ricognizione tra passato e presente, quali i progetti futuri di IANVA?
Nulla di particolarmente diverso da quanto è stato fino a oggi: qualche concerto, e poi, se le idee arriveranno e supereranno il primo vaglio critico, ossia il nostro – in particolare, di Stefania – altre canzoni. Ci sarebbe pure l’imbastitura di almeno altri due romanzi, ma francamente non so se avrò mai la forza d’animo di affrontare un’altra sconfinata serie di “notti alte”, come m’imposi al tempo della Mano Di Gloria. Da ultimo, sarebbe bello vivere abbastanza per assistere a una stagione di vera giustizia, in questo paese. Ma è altamente probabile che ciò equivalga ad augurarsi solo l’ennesima fatica sprecata.

