I paesaggi interiori di Algernon Blackwood
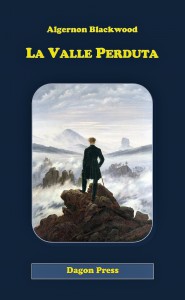 Cosa vedranno gli storici dell’editoria del terzo o quarto secolo del Duemila, studiando à rebours i nostri giorni? La bizzarra compresenza di un’editoria generalista e un nugolo di piccole e coraggiose realtà che, spesso in assoluta povertà di mezzi, realizzano autentici capolavori. Nell’ambito della letteratura dell’immaginario, poi, non parliamone. Uno dei casi più luminosi è costituito dalla Dagon Press, animata da Pietro Guarriello – tra i massimi conoscitori del fantastico in Italia – e nota soprattutto per «Studi Lovecraftiani», periodico tutto dedicato al Maestro di Providence. Per i tipi di Dagon Press è appena uscito un piccolo gioiello letterario, La valle perduta (disponibile su Lulu.com). L’autore è Algernon Blackwood, membro dell’Hermetic Order of the Golden Dawn e cronista dell’Ignoto, esploratore dell’Altrove ricordato soprattutto per John Silence, detective dell’occulto, avido lettore di teosofia e spiritualismo ma anche di Gurdjieff e Ouspensky (i quali ispirarono la sua ultima raccolta di storie originali, Shocks, del 1935), maestro dell’orrore sovrannaturale, tanto che H. P. Lovecraft non mancò di rendergli omaggio nel suo Supernatural Horror in Literature.
Cosa vedranno gli storici dell’editoria del terzo o quarto secolo del Duemila, studiando à rebours i nostri giorni? La bizzarra compresenza di un’editoria generalista e un nugolo di piccole e coraggiose realtà che, spesso in assoluta povertà di mezzi, realizzano autentici capolavori. Nell’ambito della letteratura dell’immaginario, poi, non parliamone. Uno dei casi più luminosi è costituito dalla Dagon Press, animata da Pietro Guarriello – tra i massimi conoscitori del fantastico in Italia – e nota soprattutto per «Studi Lovecraftiani», periodico tutto dedicato al Maestro di Providence. Per i tipi di Dagon Press è appena uscito un piccolo gioiello letterario, La valle perduta (disponibile su Lulu.com). L’autore è Algernon Blackwood, membro dell’Hermetic Order of the Golden Dawn e cronista dell’Ignoto, esploratore dell’Altrove ricordato soprattutto per John Silence, detective dell’occulto, avido lettore di teosofia e spiritualismo ma anche di Gurdjieff e Ouspensky (i quali ispirarono la sua ultima raccolta di storie originali, Shocks, del 1935), maestro dell’orrore sovrannaturale, tanto che H. P. Lovecraft non mancò di rendergli omaggio nel suo Supernatural Horror in Literature.
Un’atmosfera che emerge anche in questo racconto, apparso nell’omonima raccolta The Lost Valley (1910) e pubblicato per la prima volta in italiano nella traduzione di Annalisa Roffinengo, declinandosi nel fascino spettrale dei luoghi, in un singolare accordo tra geografia esteriore e geografia interiore. Un aspetto che Blackwood, come nota Pietro Guarriello nella sua introduzione, sperimentava in prima persona prima di mettersi a scrivere, lasciandosi catturare da quelle geografie ben prima di imprimerle su carta. La scelta di inserire in appendice il saggio La psicologia dei luoghi si muove proprio in quest’ottica. Perché è il genius loci, vero protagonista di questo racconto intenso e struggente, a stagliarsi dietro due gemelli, identici in tutto e per tutto, che compiono un’escursione sulle Alpi, imbattendosi in una leggendaria quanto sinistra Valle Perduta, «dove gli spiriti dei suicidi, o di chi è morto di morte violenta, trovano la pace eterna, quella pace che è negata loro in tutte le altre religioni». Un luogo antichissimo e misterioso che finirà per intrecciare ulteriormente i loro destini: un’amara riflessione sul senso della vita e del tempo, ma anche un messaggio di speranza rivolto a chi crede che il senso delle cose non è solamente materiale, e che il segreto di un istante può schiudersi solo nell’Eterno.
È un percorso tortuoso e ricco di salti dimensionali a spingere i protagonisti in un viaggio che, partendo da contrade note, si conclude nei recessi della loro anima, un cammino che dal finito si inabissa nell’aldilà e nell’eternità. I due gemelli, insomma, finiscono per sollevare il velo di Maya, andando oltre l’apparenza delle cose: non hanno parole per descrivere quest’esperienza, ma è ovviamente un trucchetto di Blackwood, la cui penna restituisce appieno il senso del transito, in pagine auree ed affilate. Qualche esempio?
«La profondità della valle si apriva come un’inquietante ombra sotto i suoi piedi; si snodava morbida e scura, in contrasto con la luce del sole. Dalla massa boschiva si levava solo un unico mormorio, come il brusio delle voci che aveva sentito in sogno, pensò. Il fruscio dei singoli alberi si fondeva in un unico suono. Una pace, antica e profonda, risiedeva in quella valle, e il suo bisbiglio gli addolciva lo spirito».
Oppure:
«La tristezza dell’autunno era presente tutta intorno a lui, e la solitudine di quella valle nascosta gli parlava della malinconia di ciò che muore – le primavere che finiscono, le estati insoddisfatte, le cose incomplete e che non appagano. Pensò che quella valle non avesse mai conosciuto presenza umana».
 Arricchito dalle illustrazioni originali di W. Graham Robertoson e da una bibliografia italiana delle opere di Blackwood, La valle perduta giunge al mistero della vita e della morte, del dolore e degli affetti attraverso il genius loci. Basta leggere La psicologia dei luoghi per rendersene conto. Da dove nasce in noi la fascinazione per un certo paesaggio? Quando torniamo dopo anni nei luoghi della nostra giovinezza, ad esempio, non è raro intravvedere il nostro Io di un tempo aggirarsi là dove l’avevamo lasciato. Già, perché il ritorno è anzitutto un incontro con una parte di noi che credevamo perduta, la quale attendeva solo che tornassimo, sorprendendola immobile, indifferente al passare del tempo. Non casualmente, è tra le esperienze più dolorose che esistano. Ma, si chiede Blackwood, che accade se, imbattendoci in luoghi nuovi, abbiamo la nettissima impressione di esserci già stati? È evidente che siamo di fronte a facoltà ben più profonde e antiche della memoria individuale: «Le cause nascoste che inducono questa percezione della psicologia dei luoghi si basano su qualcosa di molto più profondo e sottile del semplice amore per la Natura… probabilmente su milioni di delicate valutazioni di origine ancestrale e assolutamente primitiva».
Arricchito dalle illustrazioni originali di W. Graham Robertoson e da una bibliografia italiana delle opere di Blackwood, La valle perduta giunge al mistero della vita e della morte, del dolore e degli affetti attraverso il genius loci. Basta leggere La psicologia dei luoghi per rendersene conto. Da dove nasce in noi la fascinazione per un certo paesaggio? Quando torniamo dopo anni nei luoghi della nostra giovinezza, ad esempio, non è raro intravvedere il nostro Io di un tempo aggirarsi là dove l’avevamo lasciato. Già, perché il ritorno è anzitutto un incontro con una parte di noi che credevamo perduta, la quale attendeva solo che tornassimo, sorprendendola immobile, indifferente al passare del tempo. Non casualmente, è tra le esperienze più dolorose che esistano. Ma, si chiede Blackwood, che accade se, imbattendoci in luoghi nuovi, abbiamo la nettissima impressione di esserci già stati? È evidente che siamo di fronte a facoltà ben più profonde e antiche della memoria individuale: «Le cause nascoste che inducono questa percezione della psicologia dei luoghi si basano su qualcosa di molto più profondo e sottile del semplice amore per la Natura… probabilmente su milioni di delicate valutazioni di origine ancestrale e assolutamente primitiva».
Come che sia, questa vaga impressione è il primo passo di un viaggio a ritroso attraverso le ere e i recessi della nostra interiorità. Una congiunzione la cui chiave di volta è l’idea di soglia. Ogni soglia ha un aldiquà e un aldilà – e, spesso, sinistri Guardiani che ci preparano o allontanano, in base alle nostre (e alle loro) disposizioni – e tutto è soglia, l’alternarsi delle stagioni e delle età dell’anima; ogni esperienza autentica conosce a un certo punto un varco, un momento in cui il mondo conosciuto vacilla, spalancandosi sull’abisso.
«Una soglia è sempre la frontiera cruciale che invita all’avventura e quindi al possibile disastro. La frontiera, l’ingresso, la porta, naturalmente traccia una linea tra due cose opposte e può significare passare oltre e subire l’attacco di condizioni sconosciute che si trovano aldilà».
Una morte e una rinascita continue: questi i frutti della penna di quel realista magico che fu Algernon Blackwood, l’invito a non affrontare i giri di boa animici all’insegna dello sconforto ma confidando nell’avvento dell’estate dopo l’inverno, dello zenit dopo il nadir. Un inno, soprattutto, a non indugiare innanzi alla soglia. Forse così scopriremo che quella Valle Perduta altro non è altro che la vertigine del Sé, il miracolo, descritto da un bibliotecario cieco di Buenos Aires in una raccolta di poesie giovanili, «che nonostante le infinite sorti, / che nonostante siamo / le gocce del fiume di Eraclito, / qualcosa in noi perduri, / immobile». Ecco cosa ci attende in fondo alla valle, un quid eterno, superiore al dolore e all’avvicendarsi delle stagioni.

