«Il design può salvare l’Italia e le sue imprese»
L’economia italiana è ridotta in macerie, distrutta da sette anni di crisi culminati nella grande guerra dello spread combattuta dalla Germania di Angela Merkel con l’arma dell’austerity, e dalla cura di sole tasse confezionata dal governo di Mario Monti. La caduta del prodotto interno lordo, il tasso di disoccupazione a due cifre, l’esplosione dei fallimenti tra le imprese e i 131 miliardi di sofferenze lasciati nei bilanci delle banche dalla difficoltà della clientela di rispettare le rate dei prestiti sono la prova plastica del disastro. Dopo aver raccolto le proposte del numero uno del gruppo delle investigazioni Kroll, Marianna Vintiadis per riaccendere il motore dell’economia, Wall Street prosegue la galleria di interviste con Giulio Ceppi, architetto fondatore di Total Tool, società di visioning e design strategy. Perché il compito del moderno designer è di certo quello di vivere lo spazio, abitare la distanza, pensare la differenza ma anche quello di proporre idee per un futuro migliore. Tra i progetti realizzati da Ceppi c’è il nuovo Autogrill sostenibile e innovativo di Villoresi Est (clicca qui per il video), mentre tra le iniziative in corso rientrano l’autostrada sostenibile e a produzione di energia rinnovabile Kmzeroroad e lo sviluppo del brand Pepsi Cola.
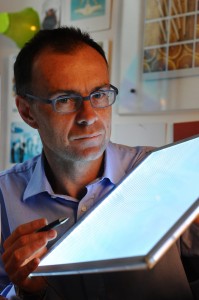 La crisi come ha cambiato la progettualità e la creatività?
La crisi come ha cambiato la progettualità e la creatività?
«Direi profondamente: si sta capendo che il design non è solo la capacità umana di risolvere i problemi e quindi di favorire il cambiamento, ma anche viceversa, ovvero che in periodi di grane e forzoso cambiamento, come quello attuale, il design è una risorsa preziosa per governare le cose».
Il design come può aiutare l’Italia a uscire dalla crisi economica? Come può favorire il Made in Italy?
«Il design è il Made in Italy, e in tutto il mondo siamo ancora riconosciuti come leader nella cultura del progetto. Dobbiamo però renderci conto che non si tratta più di dare forma ad oggetti, che non stiamo più parlando solo del “ben fatto”, ma che il design è la capacità di affrontare problemi emergenti, di risolvere questioni complesse a livello sociale, organizzativo, economico: il design è una visione, una capacità di gestire il divenire dandogli forme nuove. Dobbiamo andare oltre una visione puramente estetizzante del “bello”, per includere anche valori come il “giusto” (eticamente e socialmente corretto) e il “pulito” (ambientalmente responsabile e sostenibile)».
Quale logo penserebbe per l’Italia che si rialza?
«Abbiamo progettato sedie bellissime in Italia nella nostra storia del design: cosa le fa pensare che in piedi si stia meglio che seduti…? E se dobbiamo rialzarci lo farei senza loghi, ma con il potere della parola e del pensiero: l’immagine (soprattutto quella televisiva e di bassa qualità) ha già fatto troppi danni nell’ultimo ventennio, facendoci appunto credere che dietro ad un logo spesso vi sia altro, mentre troppe volte vi era solo il logo stesso».
In un mondo fatto di «non luoghi» un progetto come l’Autogrill Villoresi come può far rivivere un’esperienza di consumo come quella del fast food?
«Tutti noi abbiamo imparato che la nostra vita può essere fast in alcuni momenti e slow in altri, a seconda delle circostanze e dei nostri desiderata: sta a noi cosa decidere e quando. Quindi un’area di sosta come Villoresi Est, che guarda al futuro e mette il consumatore al centro di tutto, deve offrire (come abbiamo fatto con servizi di ristorazione molto diversi) l’opportunità di poter scegliere, nel rispetto come dicevo prima del “bello, giusto e pulito”. Villoresi è anche un campione di sostenibilità a livello europeo, con geotermia, copertura captante che sfrutta l’irraggiamento solare, illuminazione a led, risparmio di acqua e recupero di acqua piovana… oltre che di accessibilità, con l’abbattimento di qualsiasi barriera architettonica e la condivisione degli spazi interni senza gerarchie tra ipodotati e normodotati, bambini o anziani. È un luogo ben preciso e sono certo sarà un riferimento per chi entra ed esce da Milano, su quella che è comunque un’autostrada da 30 milioni di utenti l’anno.
«Io credo che per un progettista al centro di qualsiasi progetto, sia esso materiale o immateriale, un pezzo unico o di grande serialità, debba sempre starci l’uomo, ovvero dei valori chiari e condivisibili dai più. In tal senso tra una marca e una casa, date le differenze di genere, non vi è differenza alcuna: si progettano valori o meglio si dà forma e visibilità, sensorialità e divenire, a valori. I valori restano, le case e le marche non necessariamente».
Si parla sempre di città del futuro, di progetti sostenibili, di impatto ambientale, ma con risorse limitate come si possono conciliare queste tendenze con i limiti oggettivi dell’economia?
«Al contrario: sono forse proprio le risorse limitate che ci permettono di costruire un futuro diverso, più cosciente e consapevole. Negli anni Ottanta abbiamo scoperto che il mondo era assai più complesso di quanto credessimo, che incidenti locali avevano ripercussioni globali e che le risorse erano limitate e non infinite ed illimitate come la cultura del Moderno ci aveva forse illuso. Poi ne abbiamo perso coscienza: ora la perdita dell’abbondanza cui eravamo abituati ci insegna a ripensare ai nostri modelli produttivi, a ragionare in maniera ciclica e di produzione-uso- dismissione, a dare valore alla filiera. Forse avremo finalmente un futuro diverso e migliore: io sono molto ottimista in questo. Essere progettisti vuol dire essere ottimisti, necessariamente».
La Unicredit Tower di César Pelli a Porta Garibaldi, il nuovo grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino firmato da Renzo Piano. Le banche sono i nuovi mecenati della città moderna? E come si pensa la casa di una banca oggi?
«Le banche, oltre ad imperatori e papi, sono sempre stati grandi mecenati, sin dai tempi del Rinascimento: senza le banche non ci sarebbe stato nemmeno il Rinascimento, di cui le banche stesse sono state un’invenzione socio-economica fondamentale. Grandi architetti e finanza sono oggi un connubio inevitabile: gli uni celebrano gli altri. Le banche non progettano tanto per se stesse, ma per il proprio capitale investito e per la garanzia del suo valore futuro: ad abitare i loro uffici sono flussi finanziari ed economici, non le persone, come invece accadeva forse un tempo. L’architettura è mossa dal real estate e le città sono oramai governate e disegnate dal capitale privato, dove il Pubblico ha totalmente perso il controllo e la capacità di decidere alcunché. Più che di mecenatismo parlerei di oligopolio, onestamente».
Come sta procedendo il progetto dell’autostrada KmZero?
«Procede e questa è già una vittoria. Kmzeroroad è un’operazione di venture design: dieci aziende con il loro know how e la loro expertise messe in rete da un’idea e una visione progettuale che le guida: una forma muova per fare innovazione, per “fare sistema”, come si dice con un’espressione oramai abusata. Abbiamo partecipato ad Eire, Biennale di Venezia, Asphaltica, Expo… e avuto contatti con realtà italiane e straniere, dal Nicaragua alla Mongolia. Sono certo che riusciremo entro il 2015 a realizzare il primo chilometro, forse più facilmente fuori dall’Europa che non Italia».
Pensare al brand di PepsiCola vuol dire pensare a come far piacere un «numero 2». È una sfida impossibile o anche per chi non vince c’è uno spazio vitale da sfruttare?
«Innanzitutto cedo sia meglio ricordare che a livello globale PepsiCo è un gruppo maggiore e più forte di Coca Cola, secondo solo a Nestlé, leader indiscusso, avendo da anni investito anche nel settore food e degli snack, pur mantenendo Coca Cola la brand awareness numero 1 al mondo, che non è un fattore trascurabile. Nella mia carriera ho appreso che spesso i cosiddetti “numeri 2” sono più dinamici, aperti alla trasformazione e al cambiamento rispetto a chi è leader: basti pensare a Illy (altro mio cliente) con Lavazza. Passare dal numero 2 all’1 spesso è un lampo: pensi all’industria giapponese e a quella europea nell’auto, anche se poi la vera leadership non è un fatto quantitativo, ma qualitativo e di capacità di essere leader. Ma anche su questo si cresce».
Il design nasce dal funzionalismo, cioè dall’esigenza di corrispondere al meglio a un bisogno. Come si soddisfa o si crea un bisogno nella società post-moderna?
«Non credo per la nostra società post-moderna, come la definisce lei, si possa parlare di “bisogni”, ma semmai di “desideri”. Noi viviamo della soddisfazione di desideri e nell’atto di consumo assolviamo la nostra natura imperfetta ed aspirazione, colmiamo temporalmente stati di repressione o insoddisfazione, come spiega chiaramente un pensatore come Zygmunt Bauman, con cui ero relatore a Capri al Trendwatching Festival qualche settimana addietro. Accade che i nostri “desideri” siano tanto forti e ineluttabili da apparirci poi come “bisogni”, mentre vi sono Paesi e parti del mondo in cui i bisogni sono ancora quali primari della fame, della sete, dell’abitare. Forse il Design del XXI secolo deve imparare a guardare altrove, oltre i reflussi del consumismo».
«Nomadismo» virtuale, scomposizione e ricomposizione, deterritorializzazione sono categorie superate per descrivere l’esperienza della contemporaneità?
«Assolutamente no. Credo che il anche mio modo di progettare sia basato fondamentalmente sullo smontare e sul rimontare, sul confronto tra locale e globale e viceversa, sull’interazione tra aspetti fisici e reali e la dimensione invece della rete e del digitale: ad esempio, stiamo conducendo con Confartigianato un’interessante azione di supporto ai nuovi “artigiani digitali ” (i cosiddetti makers) e a come le nuove tecnologie trasformano il tradizionale modo di essere artigiano quanto la percezione che ne ha il consumatore, oramai potenzialmente globale».
Se la digitalizzazione rende tutto fungibile, dove risiede l’unicum umano, quell’esperienza qualificante e appagante che descrive l’esistenza?
«Forse nell’imperfezione, nell’errore, nella meraviglia, nella sorpresa … quantanche nella sofferenza e nel dolore: dimensioni semantiche che la digitalizzazione non è in grado di controllare o descrivere. Quando un computer ci tirerà uno schiaffone, dovremo cominciare a preoccuparci davvero. Chiaro che abbiamo esteso nella Rete la nostra memoria, il nostro pensiero, forse anche il nostro sesso e le relazioni in alcuni casi … ma da un lato il piacere che il nostro corpo e la conoscenza che passa attraverso di esso, nessuno la può ancora sostituire. Bisogna tuttavia continuamente lavorare sulla consapevolezza di questo e sul valore della conoscenza che passa dai sensi, come recentemente movimenti quali Slow Food o imprese come Eataly ci hanno insegnato. L’esistenza incarnata è un valore, appunto».
In conclusione una domanda «normale»: che percorso consiglia a coloro che intendono esprimere la loro creatività attraverso l’architettura e il design?
«Un percorso “normale” appunto. La creatività non è un talento innato, come romanticamente ci piace pensare, ma una pratica e un’attitudine presente in ognuno di noi e che va coltivata e curata. È un lavoro, un esercizio quotidiano, normale appunto: non un reality show».
Wall & Street





