«I prodotti sono storie»
Ora che è quasi tutto pronto per il via di Expo 2015, ci toccherà anche sopportare anche i peana per l’organizzazione Made in Italy (il Padiglione Italia comunque è splendido): si arriva sempre all’ultimo minuto, ma nessuno riesce a fare bene come noi. Insomma, la solita retorica. Ecco perché con l’architetto e life designer Giulio Ceppi vogliamo uscire dal seminato dei luoghi comuni e cominciare a pensare le nuove frontiere di tutto ciò che è prodotto e concepito in Italia.
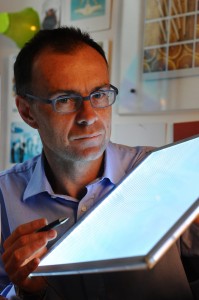 Quanto oggi il design si confronta con la scala globale?
Quanto oggi il design si confronta con la scala globale?
«La globalizzazione è una delle condizioni esistenziali, progressiva ed irreversibile, con cui il progetto si deve inevitabilmente confrontare.
Sul piano massmediale e comunicativo una Storia della globalizzazione è forse ancora da scrivere, ma momenti come lo sbarco dell’uomo sulla luna, la morte del presidente Kennedy, il crollo delle torri gemelle… sono eventi vissuti da milioni di spettatori in tutto il mondo e indelebilmente posizionati nel nostro immaginario collettivo. Con la scoperta della complessità ambientale, del fatto che non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, la società occidentale si è resa definitivamente conto di non essere più proprietaria esclusiva del pianeta, ma di doverlo condividere, anche nei suoi aspetti problematici, e che cause locali possono avere effetti globali, a grande scala».
Questo cambio di scala nella percezione dei prodotti modifica il modo di operare del design?
«La questione ecologica, la saturazione fisica e semantica del pianeta, come il contrasto tra opposti integralismi, hanno posto e pongono imbarazzanti domande sul senso del produrre: abbiamo ancora bisogno di oggetti? Gli oggetti che produciamo rispondono a bisogni o a pulsioni di puro consumo? Per i progettisti, come per i produttori, la nozione di prodotto sta cambiando rapidamente: non sono più i bisogni che vanno soddisfatti, almeno nei nostri paesi ricchi, ma piuttosto i desideri che vanno sollecitati, riscoperti od inventati. Gli oggetti diventano quindi per necessità veicoli di valori, strumenti per esprimere estetiche e modelli di vita. Il prodotto, pezzo unico o seriale, industriale o artigianale, acquista la sua identità se rappresenta un percorso produttivo e culturale, se possiede una storia chiaramente trasmissibile al consumatore».
Allora tutto è storytelling? Quanto conta oggi coinvolgere il consumatore nella propria visione del mondo, nella filosofia della marca?
«Per chi progetta non contano più solo gli aspetti formali, fisici e geometrici del prodotto: il prodotto è oggi un sistema complesso, un insieme di funzioni di natura formale, comunicativa, distributiva, di servizio. Diventa un luogo, carico di problematicità come di fascino, locale ma con implicazioni necessariamente globali. La relazione, la capacità di scambio emotivo e culturale, è la vera ed esclusiva qualità prioritaria del prodotto contemporaneo: conta il saper raccontare una storia. Il valore del fare, del produrre e del progettare, risiede allora nella volontà di costruire percorsi di senso, prodotti che siano storie, luoghi, insiemi di valori condivisibili: il prodotto diventa un veicolo, un medium, per costruire narrazioni, esperienze che raccontino desideri e aspettative a chi forse non sa più cosa sia necessario e cosa superfluo.
Mi sembra di capire che si tratti di andare un poco oltre al concetto commerciale dell’export, giusto?
«Sappiamo che la sfida del design e dell’impresa italiana è nell’internazionalizzazione: tuttavia non si tratta solo di puntare sull’export e di cercare meramente di vendere i propri prodotti attuali fuori dal nostro Paese, ma di voler creare situazioni a 4 mani ex novo, di aprirsi ai mercati emergenti perché si costruiscono progetti su misura, si generano collaborazioni dinamiche ed innovative. Per le aziende italiane, spesso piccole e familiari, questa strada è forse più facile che non l’illusione facile, ma ingenua, di colonizzare fasce di nuovi consumatori fuori dall’Europa seguendo le chiare istruzioni dei manuali del marketing americano. Non quindi un’azione monodirezionale, che dall’Italia esporta merci verso il mondo, ma il contrario: intelligenza e know how italiano che costruiscono nuove piattaforme economiche di sviluppo e servizio fuori dall’Italia, per vendere maggiormente anche in Italia per paradosso, ma ovviamente non solo».
 Ci potrebbe fare un esempio concreto di quanto dice?
Ci potrebbe fare un esempio concreto di quanto dice?
«Come caso concreto citerei You Khanga, giovane start up dove si vogliono combinare due culture distanti e farle convivere in un unico progetto: la fantasia del tessuto khanga (rettangolo di cotone stampato dai colori vivaci e decorato con frasi, proverbi e indovinelli beneauguranti scritti in lingua Swahili che diventa in Africa abito o copricapo per portare i bambini sulla schiena) incontra il saper fare dei maestri calzaturieri italiani. Nascono così le ballerine You Khanga, con tessuti rigorosamente made in Kenya che animano, all’insegna dell’unicità, (perché ogni khanga è unico e irripetibile, piccole imperfezioni comprese…) l’idea di una nuova eleganza dove ogni scarpa è tagliata in un punto diverso della stoffa rendendo, anche di poco, ogni paio irripetibile, anche perché nessun khanga è uguale all’altro. Un progetto di questo tipo non solo coniuga tradizione africana, creatività e maestria italiana, vendendo poi in tutto il mondo un prodotto Made in Italy, ma contribuisce allo sviluppo delle popolazioni locali. Per questo i sacchetti, anch’essi confezionati con i khanga, sono invece prodotti direttamente e in modo artigianale, in Kenya. Inoltre una parte dei proventi dell’acquisto delle creazioni You Khanga sono impiegati in progetti di beneficenza dedicati alle donne e ai bambini del Kenya».
Allora è il concetto di Made in Italy che deve evolvere, aprendosi ad altre logiche e ridefinendosi in forma nuova?
«You Khanga ci mostra chiaramente come design italiano, a differenza di altri paesi europei e di una scuola di pensiero anglosassone, fortissima anche negli Usa, abbia preso invece, strada poi seguita anche in altri paesi europei di matrice latina e mediterranea, una prospettiva alquanto libertaria e radicale, di ricerca di valori sociali e personali. La visione italiana del design è sempre stata innanzitutto sociale e politica, culturale e comunicativa, e solo in seconda istanza di natura tecnica (ergonomica) o commerciale (marketing): l’individuo viene posto al centro del mondo, e non l’industria in sé, come forse qualcuno ancora crede.
Passare dal Made in Italy al Making by Italians è una delle sfide del futuro, dove il “saper fare italiano” nutre e sostiene altre culture, generando nuove occasioni di business per entrambe».
Wall & Street





