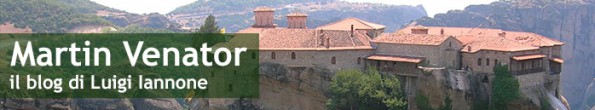L’ora delle decisioni (quasi) irrevocabili
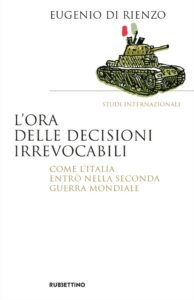
Si può essere certi che il frastuono mediatico e le polemiche politiche che accompagnano ricorrenze come quelle, per esempio, del 25 aprile c’entrino poco o nulla con l’approfondimento analitico ma, anzi, lo sotterrino sotto una coltre di insinuazioni deformanti ogni qual volta si tenta di cogliere la verità storica in tutta la sua complessità e spogliata da capziosi posizionamenti di parte. È così che lavori storici che dovrebbero propendere per loro stessa natura sul versante dell’imparzialità vanno spesso a rimorchio del contesto politico agitando le pulsioni più meschine del dibattito generale e rispondendo a prevedibili logiche manichee.
Revisionare, tramite documenti, ciò che è stato fino a un attimo prima marchiato con i crismi della inconfutabilità, è compito primario di una sana storiografia. Tutto ciò servirebbe a modificare gli intendimenti su alcuni fatti senza, al contempo, sminuirne la tragicità, l’orrore e il ribrezzo.
Eugenio Di Rienzo con L’ora delle decisioni irrevocabili. Come L’Italia entrò nella seconda guerra mondiale (volume in uscita nei prossimi giorni per le edizioni Rubbettino) tenta di far chiarezza su aspetti poco esplorati o, nel migliore dei casi, tenuti ambiguamente lontani dal riflettore della verità storica.
La cornice ufficiale è nota. Mussolini dichiara l’entrata in guerra il 10 giugno 1940 con l’intento di portare l’Italia al rango di un Impero detentore di possedimenti e risorse, ed è perciò pronto a sedersi al tavolo dei potenti. Ma, in quel contesto, la geopolitica ha sempre contato più delle dichiarazioni d’intenti grondanti di retorica e profuse a uso e consumo del dibattito casalingo interno. A ciò si aggiungono errori di prospettiva di non poco conto come la convinzione che la immane potenza bellica nazista avrebbe soverchiato tutte le altre forze in campo e che la guerra sarebbe stata vinta in breve tempo
La disavventura bellica parte formalmente dal balcone di Piazza Venezia quando annuncia l’entrata nel secondo conflitto mondiale con il celebre incipit: «Combattenti di terra, di mare, dell’aria… » ma i prodromi sono tutti da ricercare negli anni precedenti quando – a scorrere le pagine del libro – di irrevocabile o, almeno, di definito, c’è poco o nulla.
Di Rienzo mette in fila una serie di verità non ignote alla storiografia meno reticente ma con astuzia sotterrate dalla fitta massa informe che agita il dibattito pubblico. Mette paletti su molti aspetti, riparametra fatti che con lo scorrere del tempo sono stati degradati ad aneddoti irrilevanti ma sempre partendo da una premessa: negare che l’Asse ideologico con il nazismo fosse il naturale preludio all’entrata in guerra: «Anche dopo la rottura del nostro Paese con le Potenze occidentali, determinata dal conflitto italo-etiopico e dalla guerra civile spagnola, l’Asse Roma-Berlino, rimase infatti, un matrimonio di interesse, un’entente cordiale, solo nella superficie, attraversata da sospetti e timori, soprattutto da parte italiana, e da una forte e reciproca concorrenzialità riguardo all’egemonia sull’area balcanico-danubiana».
Data per assodata la scellerata scelta di scendere in campo in una guerra che si rivelerà disastrosa sotto tutti i punti di vista, ciò che risalta è – almeno nelle primissime fasi di avvicinamento a Hitler – la ricerca di una certa flessibilità di alleanze. O meglio, sopravvalutando le sue capacità machiavelliche di sapersi districare tra imperativi categorici e ammiccamenti disseminati tra nemici e alleati, si svela il tentativo di giocare sempre su più tavoli. Lo dimostrerebbe il trattato d’amicizia del 24 ottobre 1936, il discorso milanese del 1° novembre e tanti episodi, più o meno noti, come le perplessità di Galeazzo Ciano, riferite a più persone, a cominciare dall’addetto stampa presso l’ambasciata italiana a Vienna, o le fortificazioni al Brennero volute dal capo del fascismo e anche le trattative (sempre di Ciano) con emissari del Regno Unito. Elementi di un mosaico che, fino ad una certa fase, potevano far presagire anche a un cambio netto di alleanze o all’approdo alla neutralità: «Quello che Mussolini sperava era che l’offensiva della Wehrmacht fosse arrestata dalle forze anglo-francesi, come era accaduto nel settembre 1914, e che Hitler posto di fronte all’eventualità di una lunga e sfibrante guerra di logoramento si sarebbe piegato a sedere al tavolo della pace, dove l’inquilino di Palazzo Venezia avrebbe assunto il ruolo di Kingmaker, ottenendo per l’Italia un riequilibrio di potenza nel Mediterraneo e vantaggi territoriali nell’Africa settentrionale e orientale».
Previsioni sballate non tanto perché circoli ancora adesso la chiacchiera che i generali avessero nascosto a Mussolini l’insipienza delle forze armate italiane il quale era, invece, del tutto consapevole della scarsezza e arretratezza dei mezzi e di un apparato industriale non all’altezza di sostenere lo sforzo sul medio-lungo periodo, ma perché per lunghi anni il duce (e lo stesso Ciano) parlarono di guerra, pensando alla pace e, al contrario, credettero di poter preparare la pace intimando la guerra. Da una parte, con «la speranza di poter condurre una “guerra simulata” contro gli Alleati che avrebbe portato in breve a una pace di compromesso» e, dall’altra, preconizzando la vittoria della Germania e la solidificazione dell’Asse con l’Unione sovietica, dopo che vi era già stato l’accordo Molotov-Ribbentrop, e magari muovendosi tramite Augusto Rosso, nostro ambasciatore a Mosca, per un patto di collaborazione economico «con cui l’Italia “in cambio del riconoscimento della sua situazione di preminenza nel Mediterraneo” era disposta a garantire alla Russia eguali prerogative nel Mar Nero, negli Stretti Turchi, ingrandimenti territoriali a scapito della Romania e la sigla, d’intesa con Berlino, di un accordo generale per l’area balcanica-danubiana».
Tutto questo – in un modo o nell’altro – non poteva avvenire, e non avvenne, perché il ruolo di Kingmaker che avrebbe voluto assumere Mussolini in quasi tutte le questioni continentali fu nel giro di breve tempo assunto dagli Stati Uniti.