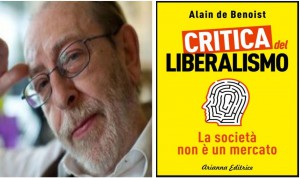De Benoist e la critica al liberalismo
È ancora possibile impedire che il nostro pianeta e la nostra società si trasformino in un immenso mercato? Esiste un legame tra la propaganda liberalista e il cosiddetto pensiero unico?
Parla di questi temi Alain de Benoist nel suo ultimo libro, Critica del liberalismo. La società non è un mercato, uscito per Arianna editrice qualche giorno fa, e di cui riproduco di seguito la prefazione di Eduardo Zarelli
* * *
Le ragioni impellenti di quest’ultima opera di Alain de Benoist, portano avanti la disanima tanto puntuale quanto sistematica sulle condizioni del nostro tempo sviluppate nel precedente Populismo. La fine della destra e della sinistra. Qui si descrive con capacità esaustive il liberalismo come ideologia dominante nell’estremo Occidente, unitamente all’inverarsi oligarchico del potere contro la sovranità e la partecipazione popolare, dove la democrazia è concettualmente intesa come la forma di governo corrispondente al principio dell’identità di vedute fra governanti e governati, istanza primaria di un popolo in quanto unità politica.
Le ideologie sono state le protagoniste della politica moderna, e hanno caratterizzato il conflitto nella società di massa contemporanea. Tra le molte sorte, e poi tramontate, ad avere mobilitato le generazioni sono state quelle espresse dal liberalismo (sinistra e destra), dal comunismo (compresi socialismo, marxismo e socialdemocrazia) e dal fascismo (insieme al nazionalsocialismo e alle declinazioni varie della “terza via”). Il liberalismo è quindi la prima teoria politica.
Nata già nel XVIII secolo, essa si è dimostrata la più aderente al determinismo della modernità persistendo e prevalendo su tutti i suoi avversari, e sedendosi su un trono grande quanto il mondo. Non ha più una dimensione politica e rappresenta non più una libera scelta, ma l’unico campo in cui si può giocare la partita dell’umanità: l’utilitarismo economicista.
Con la vittoria del liberalismo, l’individuo è diventato il soggetto di riferimento per tutta l’umanità, emancipato da ogni appartenenza comunitaria e identità collettiva, catalizzato dall’ideologia dei diritti umani e dall’onnipervasiva catechesi del “politicamente corretto”. Il liberalismo è cioè riuscito nell’intento di sostituire il “politico” con l’autoregolazione giuridico-amministrativa del presente e con il moralismo, tanto da essere ormai – paradossalmente – più che una idea politica, una sussunzione totalitaria della realtà. Permeandosi nel profondo del tessuto sociale e dei comportamenti indotti, il liberalismo è oggi l’ordine “naturale” delle cose, la dittatura dei nostri tempi. La politica diviene biopolitica – delle “particelle elementari”, direbbe Michel Houellebecq – mezzo con cui il sistema regola la vita biologica e fisica – attraverso dei nuovi istituti giuridici, il condizionamento tecnologico, la medicalizzazione di ogni atto e momento dell’esistenza, il controllo della stessa riproduzione, la polverizzazione della famiglia – e dove lo scambio, la produzione, il consumo, la rapida sostituzione del “materiale umano” (eugenetica, eutanasia, immigrazione di massa) disegnano un vitreo e distopico palcoscenico post-umano. Un vero e proprio mutamento antropologico, prodotto dalla civilizzazione e dal dominio onnipervasivo del materialismo pratico e del riduzionismo tecno-scientifico. L’individuo mutante post-umano che si prefigura in questo presente distopico non sarebbe possibile, all’oggi, senza la premessa filosofica liberale per cui il soggetto ha il diritto di perseguire la propria massima felicità senza limiti e pregiudizio per gli altri, la natura e l’Essere. L’antropologia individualistica e utilitaristica è insofferente alla natura e il senso comune della realtà, infervorato da una tensione titanica all’illimitato, nega la forma e la sacralità del vivente, generando sistemi economici, politici e giuridici destinati a una catastrofe ecologica e a contraddizioni sociali irrisolvibili, nell’irresponsabile presunzione che basti affidarsi alla tecnica per risolvere i problemi che la tecnica stessa crea.
Sotto l’effetto della religione dei diritti dell’uomo, si è definita una concezione strumentale della democrazia, intesa non più come popolo al governo di un bene condiviso grazie alle libertà pubbliche. La declinazione oligarchica della democrazia è diventata culto individualistico dell’universalismo, disprezzo dell’appartenenza collettiva e quindi della sovranità popolare. Essendo questi valori globalitari, nessun Popolo può sentirsi legittimo, giacché solo l’umanità lo è. Questi valori, dunque, sono stati posti al di sopra della sovranità dei cittadini istituzionalizzando la degenerazione oclocratica della democrazia.
Dal 1989, il liberalismo è quindi storicamente l’ideologia onnipervasiva occidentale e della struttura finanche fisiologica del potere, un insieme di valori, un modo di governare e un’antropologia culturale. Questa egemonia si è contorta su se stessa con la crisi economica sorta nel 2008 per la bolla speculativa e con l’emersione populista dell’ultimo decennio. L’autoreferenzialità ideologica del potere liberale si dimostra nel non avere colto la gravità del divario tra rappresentanza parlamentare, partecipazione e governo, sostenendo anzi un ulteriore appoggio alle istituzioni non elettive – e alle tecnocrazie che le amministrano – come banche, agenzie finanziarie, corti giudiziarie, e organi come l’ONU, il FMI, la BM, l’OCSE, l’Unione Europea e la NATO.
Il liberalismo, che nella sua ideazione politica poneva la tutela istituzionale delle minoranze rispetto alle maggioranze, si sottrae ora all’istanza partecipativa popolare, dato che si identifica con minoranze non elette – banchieri, finanzieri, imprenditori, scienziati, esperti, opinionisti – che si ritengono titolate a decidere per le maggioranze o esplicitamente contro di esse. La legittimità si riduce quindi alla legalità. Questa concezione positivistica-legalistica della legittimità invita a rispettare le istituzioni per se stesse, come se costituissero un fine in sé, senza che la volontà popolare possa modificarle e controllarne il funzionamento. Privatizzando l’economia e deregolamentando il sistema finanziario, d’altronde, si impone un meccanismo autoreferenziale di prestazione tecnica e realizzazione del profitto, che si sottrae alla giustizia sociale e al consenso popolare. Il mercato autoregolato pretende di imporsi indipendentemente dal contesto sociale e dalla sovranità politica, riducendo la volontà generale a un’opinione pubblica da persuadere, ma in realtà da manipolare. Dalla pretesa illuministica di go-vernare indipendentemente dai sentimenti del popolo alla volontà di affermarsi contro il medesimo. L’ideale della governance, il modo cioè di rendere “non democratica la società democratica” è oramai nei fatti: senza sopprimere l’apparenza procedurale, si pratica un sistema di governo indifferente al popolo – o, se è il caso, contro di esso – in nome di una etero-direzione transnazionale economico-finanziaria.
Non è certo un caso che questa eterogenesi democratica dei fini liberali si sposi con l’occidentalizzazione del mondo, con l’espansione anche cruenta della liberal-democrazia che caratterizza lo scenario internazionale. L’esportazione della “democrazia” e dei “diritti dell’uomo” (ai tempi del primo colonialismo, si diceva della “civilizzazione” e del “progresso”) strumentalizza l’universale in funzione di meri interessi politici ed economici parziali ed egemonici. L’universalismo dell’oggi è in realtà il nazionalismo della potenza mondiale dominante. Imporre la democrazia a un popolo, non può che portarlo a considerare la “democrazia” come una forma di aggressione. Il dominio liberale ha divaricato esponenzialmente le disuguaglianze, le democrazie si sono adattate a oligarchie tecnocratiche e le relazioni internazionali si sono piegate all’unilateralismo e all’asimmetria dei rapporti di forza.
L’utilitarismo e l’individualismo, alla base fondativa del liberalismo, sono fisiologicamente avversi alla responsabilità sociale, ai legami comunitari e al bene comune. Il liberalismo subordina la società alla realizzazione edonistica dell’individuo, che fa degenerare la libertà in liceità, un “dispotismo dolce” – per dirla con Alexis de Tocqueville – che si installa al di sopra della folla solitaria di uomini simili plagiati nell’ortodossia del “medesimo”, mentre lo scopo è il bene comune della democrazia classica, in cui la persona svolge il proprio fine (telos), la vita buona che si riconosce nella comunità di cui è parte. Nello Stato democratico è il popolo a essere sovrano. Altra cosa avviene nel regime liberale, in cui sovrano diventa il numero a profitto. La modernità pone il limite della libertà soggettiva dove comincia quella dell’altro, mentre l’appartenenza comunitaria ti pone in obbligo verso gli altri, ragione per cui la libertà è intesa come responsabilità che si fa disinteressato dovere civico. Il liberalismo, per vizi privati e pubbliche virtù, promuove la realizzazione della ricchezza individuale come emancipazione del singolo da ogni misura e norma etica, mentre la democrazia degli antichi mira a evitare che il Re diventi un tiranno, che il singolo diventi un despota in sé e per gli altri, considerandoli uno strumento per il suo utile e degradando la potenza su di sé alla “volontà di potenza” su una realtà reificata e quindi annichilita.
La forza del dettato dei nostri tempi si iscrive nell’apparente inerzia e irreversibilità dell’esistente, ma l’idea di un sistema capitalistico capace di rigenerarsi all’infinito cova la possibile inversione di tendenza, perché implica un meccanismo di accumulazione materiale e di espansione nello spazio che deve necessariamente urtare contro un limite, fosse anche planetario. Avere di più non significa vivere bene. In presenza del declino della vita associata e della giustizia sociale, dovuto alla sussunzione nella forma capitale di ogni intendimento e azione individuale e collettiva, è legittimo immaginare – in controtendenza – una democrazia olistica, in cui il criterio dell’agire politico sia rappresentato non dall’espansione dei diritti individuali, ma dalla promozione e dalla difesa della comunità di appartenenza? Sì, è legittimo immaginarla, anzi dobbiamo, se conserviamo ancora un intendimento della dignità umana non degradato a mere pulsioni mercificate. La democrazia partecipativa non ha soltanto una portata politica, ne ha anche una sociale; favorendo i rapporti di reciprocità, permettendo la ricreazione di un legame sociale, essa può aiutare a ricostruire delle solidarietà organiche oggi debilitate e a ricreare un tessuto relazionale disgregato dallo sviluppo dell’individualismo e dalla corsa nel vuoto della concorrenza e dell’interesse.
È quindi indispensabile individuare delle procedure qualitative e non meramente quantitative di consenso, riattivare la partecipazione comunitaria e valorizzare il vissuto, il locale e il territoriale nella sostenibilità e nella resilienza, nel respiro di un grande spazio continentale autosufficiente e internazionalmente multilaterale. A tale fine, gli strumenti concreti sono la sussidiarietà e la priorità della partecipazione sovrana rispetto alla delega e alla rappresentanza, per cui il merito e la capacità coincidano con lo spirito di servizio. Appartenenza, socializzazione, reciprocità e partecipazione sono i caratteri di fondo della “democrazia organica”, per dirla con Alain de Benoist Per partecipare, è indispensabile riconoscersi nel contesto in cui l’interazione avviene; di conseguenza, risulta essenziale ricostruire la comunità, nella quale il bene comune non è subalterno a quello individuale e anzi l’individuo assume coscienza di sé proprio perché appartiene a un’identità culturale collettiva. In una società in cui l’idea di Patria sia volontaristica, disinteressata e inclusiva, la solidarietà non decade in un astratto umanitarismo moralistico apolide, ma si esprime in un “comune sentire” e si incarna politicamente nella giustizia sociale e nell’autodeterminazione dei Popoli.