Confessioni sulla pandemia
Da pochi giorni nelle librerie, La vita quotidiana ai tempi del coronavirus (Solfanelli editore, p. 175, euro 12), l’ultimo libro di Giuseppe De Ninno, saggista e traduttore che, in passato si era cimentato su lavori di taglio storico (Risorgimento e Controrivoluzione) e di critica cinematografica (Piombo, sogni e celluloide) e che, adesso, in un quadro più intimistico, volge la sua attenzione a timori, aspettative, paure provocate da questo anno claustrofobico segnato dalla pandemia globale.
Un racconto tra indignazioni e speranze, pubbliche e private, di cui – qui di seguito – anticipiamo le prime pagine.
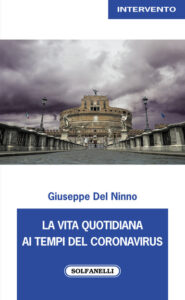
* * *
Premessa
Si può “fare storia” a partire da un diario? Molti precedenti, ben più illustri di questo, consentono di rispondere affermativamente, e qualche esempio si troverà anche nelle pagine che seguono. Dunque, si può scrivere la storia come testimonianza privata, specialmente quando ci si trova di fronte ad un avvenimento grandioso e imprevisto, come una guerra o, nel nostro caso, una pandemia.
Si può “fare letteratura”, sempre adottando la forma narrativa del romanzo? Anche qui gli esempi si moltiplicano e anche di questo riporteremo qualche esempio nel libretto che, se non aureo, aspira ad essere “argenteo” (e speriamo non di bronzo, come le facce di certi personaggi che nel racconto incontreremo).
Nel diario, si troverà di tutto: sensazioni intime e pubbliche indignazioni, gusti e disgusti per questo o quel libro, questa o quella serie tv, questo o quel protagonista delle cronache. Ci saranno “pensierini” sulla politica e la religione, la famiglia e la scuola, lo sport e l’amore, i giovani e i vecchi, le piante, gli animali e le stagioni; ci sarà persino un accenno alla poesia, ma la protagonista in assoluto sarà la casa, dimora eletta della quarantena, assurta a microcosmo protettivo, ma claustrofobico per molte settimane.
Parlerò dunque della mia casa, della mia famiglia e della mia città, perché fin dai banchi del liceo mi hanno insegnato che se vuoi essere universale, devi parlare delle cose che conosci bene, e quindi del tuo “particolare”. Spero di esserci riuscito, aldilà delle drammatiche circostanze che sono all’origine di queste pagine.
Prologo a Venezia, Febbraio 2020
Questo diario di una lunga limitazione della mobilità comincia, paradossalmente, con un viaggio: torniamo in una delle nostre città del cuore, grazie a nostro figlio Alessandro, che riprende il suo insegnamento alla Ca’ Foscari. La sua prima lezione è fissata domani, in concomitanza con l’inizio del Carnevale, e noi lo seguiamo ben volentieri. Non lo sappiamo ancora, ma proprio in questi giorni ci sarà l’avvio della pandemia da coronavirus, in particolare in Lombardia e Veneto. Usciamo dalla Stazione di S. Lucia in una classica serata veneziana, umida e affollata. Mentre aspettiamo d’imbarcarci per l’appuntamento con la ragazza dell’agenzia, che dovrà consegnarci le chiavi dell’appartamento preso in affitto, ci assale l’altrettanto classica nostalgia tipica di questa città e di chi la visita; ma la nostra non si può riferire agli “amori morti”, come cantava Aznavour: piuttosto alle “amicizie morte”, cioè a quegli amici veneziani già compagni di lontane avventure intellettuali e poi persi di vista da anni. E dunque, nostalgia di tempi andati.
Ben presto ci facciamo ammaliare dal fascino della sera veneziana, con lo sguardo che dal vaporetto vaga tra canali, ponti e luci a illuminare facciate aristocratiche, anonime dimore, il mercato del pesce. Poche fermate fino a Cannaregio, dove ci aspetta l’addetta dell’agenzia che ci mostrerà la bella casetta su due livelli, dove alloggeremo per tre giorni, in una stretta calle che si apre sul campo, “drio la chiesa” dei SS. Apostoli.
Qui però, aldilà degli spunti diaristici, vogliosoffermarmi sul mio primo carnevale nella città delle acque e della Repubblica marinara. Ho sempre avuto del Carnevale l’idea di una squallida coazione al divertimento, nel migliore dei casi di una festa per i bambini e solo in funzione loro sopportabile. So bene che vi è tutta una cultura simbolica, che nella scelta di una maschera vede una dionisiaca assunzione degli stati di coscienza più profondi e nascosti nonché, in chiave sociologica, l’eccezione ad una generale regola condivisa, magari con un rovesciamento dei ruoli sociali. E poi… semel in anno licet insanire… Tuttavia, nella mia personale interpretazione di questa festa, restavano e restano a spiegarne il mio infastidito distacco la trasandatezza di travestimenti arrangiati e l’inconsapevole nevrosi del divertimento ad ogni costo (e — perché no? — una diffusa tendenza a prendersi troppo sul serio…).
Qui non è così. Fin dalla prima sera, eccoci in un flusso di maschere in movimento su ponti, campielli e calli; e tutti i costumi mi appaiono curati nei minimi dettagli e sono perlopiù ispirati al Settecento, il secolo d’oro della Repubblica dei Dogi, l’ultimo dell’eleganza maschile associata ad una sia pur superficiale sicurezza di sé ed alla gioia di vivere. Veniamo quasi trascinati in un tripudio di ricami e spadini, tricorni e calzamaglie, fibbie, parrucche e alamari, in una festa di blu e di avori, di rossi e di verdi, dove perfino il nero colpisce per il suo insolito vigore cromatico, esaltato com’è da nastri e bordure d’oro e d’argento.
Qui poi ancor oggi la maschera appare, come tre secoli fa, come strumento di misteriosa seduzione, ma anche di gioco, di rimescolamento sociale e generazionale (molti dei volti intravisti sono probabilmente di maturi e agiati commercianti e professionisti, ma anche di giovani commesse e garzoni) e di sfida alle forze maligne della vita, sorriso beffardo in faccia all’età che avanza e finanche alla morte, esorcizzata nei teschi di cartapesta e nelle maschere dei “dottori della peste”, quelle col naso lungo (nella memoria collettiva veneziana, è rimasta la peste del 1700, quella che diede luogo, per la prima volta dopo quella evocata dal Manzoni, al lazzaretto).
E le dame? Le più attempate non temono di mostrare maquillagee sorrisi, sotto ardite parrucche, e le vedi passeggiare, nei loro variopinti abiti di velluti e broccati, compiaciute e incuranti dei paragoni con le più giovani e avvenenti, che sfoggiano gli stessi generosi décolletésdelle antenate, tutte pronte e disposte, con i loro cavalieri, a offrirsi all’avido obiettivo dei mille telefonini (compresi i nostri).
Soltanto a Venezia poi il carnevale assume anche le sembianze di un sorridente orgoglio identitario: si prende un po’ in giro la storia, che conobbe delazioni e ingiustizie — come nel caso del famoso fornaretto — ma anche i trionfi dell’abilità mercantile e della potenza marittima, che portò il nome di Venezia in tutto il Mediterraneo, le cui coste sono ancora costellate delle sue architetture militari, civili e religiose.
Certo, il tono del carnevale era, e solo in parte è, dato dall’esaltazione dell’eros — praticato dal se- duttore principe,Casanova, e cantato dal suo con- temporaneo Giorgio Baffo, poeta licenzioso — e del corteggiamento, che vedeva in prima fila le figure del “cavalier servente” e degli abati cicisbei.
Ma quella Venezia conosceva pure atti di generosità pubblica verso i più sfavoriti, legati alle gioiose solennità carnevalesche: ne rimangono tracce ancor oggi, sia nel linguaggio che nella salvaguardia di certe consuetudini. Una per tutte: il concorso delle “Mariette”, cioè delle fanciulle più bisognose, per le quali il Doge offriva un lauto pasto alla cittadinanza (il “bagordo”), provvedendo alla necessaria dote per la vincitrice. A costei era poi riservato, l’anno successivo, il volo dell’Angelo o della Colombina, e cioè l’acrobatica discesa lungo un cavo dalla cima del campanile di S. Marco giù fino alla piazza (una cerimonia che anche ai nostri giorni apre le celebrazioni carnevalesche).
Insomma, ancor oggi qui si avvertono gli echi del secolo di Goldoni e Mozart, Casanova e Cagliostro, felice con tutte le sue contraddizioni, almeno fino a quando questa felicità non fu soffocata nel sangue della ghigliottina e poi nel tradimento napoleonico. In questi giorni, tuttavia, si rievocano soltanto scherzi, feste e banchetti, e i sospiri non sono più quelli dei condannati ai Piombi, ma quelli degli innamorati, di un giorno o di una vita.
Così anche noi ci abbandoniamo alla corrente dei cento affluenti che s’infrangono contro le barriere dei “tutori dell’ordine”, per poi sfociare nell’unico accesso consentito nella piazza, sotto le cupole della basilica ispirata all’Oriente e i merletti marmorei del Palazzo ducale: da un lato il mare, che fondò la ricchezza e il potere di quella Repubblica, dall’altro le possenti Procuratie, che delimitano la piazza, tutti col naso in su, a seguire il volo della Colombina.
E alla nostra mente, di tanto in tanto, si affacciano le immagini di un’altra basilica, che ci attende lunedì a Roma: quella di Santa Teresa d’Avila, teatro di tante cerimonie familiari, tristi e allegre, e che stavolta ospiterà i funerali di Prisca, zia carissima di mia moglie, che abbiamo appreso averci lasciato proprio in nostra assenza. In fondo, dietro ogni maschera di Carnevale, c’è Lei, la Signora in nero con la falce, con la quale, per brevi momenti, si riesce anche a giocare, un po’ come fece il Cavaliere del Settimo Sigillo nel capolavoro di Bergman.

