Considerazioni su de Maistre
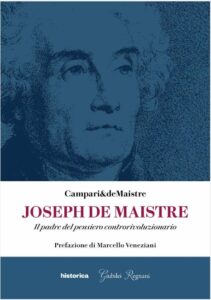
Joseph de Maistre muore il 26 febbraio 1821 ed è davvero surreale come, passati duecento anni, un pensatore di tale grandezza sia sconosciuto ai più, o raramente faccia capolino nel dibattito culturale.
In Italia avemmo contezza di questa singolare assurdità sin dagli anni sessanta. A svelarcene le trame con un aneddoto illuminante fu Alfredo Cattabiani, curatore per la Rusconi de Le serate di San Pietroburgo. Confessò di aver scelto de Maistre come oggetto della sua tesi di laurea all’università di Torino e che tale atto fu considerato una inaccettabile provocazione. Il “democratico” Norberto Bobbio, che era controrelatore, all’atto della discussione, prese copia della tesi e la buttò a terra, spiegando che non avrebbe proferito alcuna parola su un «teorico della schiavitù». La vicenda si chiuse positivamente solo grazie a Luigi Firpo e ad Alessandro Passerin d’Entreves.
Quell’episodio, tuttavia, non derivò da un irrigidimento occasionale ma da un ostracismo che aveva pervaso le accademie e si era già riprodotto nelle redazioni editoriali. L’opera del Conte savoiardo si è infatti via via raggrinzita nei luoghi comuni e ritenuta espressione di un oscurantismo del più infimo livello. Ciò è accaduto per una serie di ragioni apparentemente oggettive. Innanzitutto per la nettezza di posizioni. Se solo rileggiamo i suoi giudizi su singole personalità come Voltaire («Sospeso tra l’ammirazione e l’orrore, qualche volta vorrei fargli innalzare una statua… dalle mani del boia»), su Locke («Che tanfo di magazzino!»), sulla lotta all’empietà e all’ateismo, abbiamo chiaro questo zelo.
In secondo luogo perché è cambiato il contesto generale e quindi chi oggi tenterebbe di riproporre nella forma e nella sostanza una analoga formulazione di quelle tesi rischierebbe l’internamento in qualche padiglione di salute mentale. Talune sue argomentazioni dal taglio apologetico, pur apprezzabili per disciplina e nerbo, rischiano effettivamente di risultare datate se non proprio incomprensibili a chi si muove nel magma relativistico del nostro tempo.
In terzo luogo, non pochi brani, concetti o formulazioni vengono spesso meccanicamente riprodotti, mai sfrondandoli da appesantimenti retorici, rendendoli poco funzionali al contesto post-moderno.
Tuttavia si può promuovere una frequentazione meno convenzionale così come hanno fatto in un volume collettaneo (Joseph de Maistre, Historica, p.190) un gruppo di giovani studiosi cattolici sotto il nome, per l’appunto di Campari&deMaistre, nel tentativo di sbrogliare ogni singolo nodo analitico e di fissare la centralità delle formulazioni intorno alla data fatidica del 1789 e ai teoremi che da essa sono discesi. Perché è da lì che si deve partire!
De Maistre era entrato in Senato ereditando la carica alla morte del padre e qualcuno lo considerava nemico dell’assolutismo. Addirittura, aveva visto con favore le lotte di coloro i quali si dichiaravano per una costituzione all’inglese. Ma è il 1789 a cambiare tutto, ed è la lettura delle Reflections di Edmund Burke a temprare le sue intuizioni. La rivoluzione inglese del 1688 e quella francese andavano ormai lette su piani separati. La prima metteva un freno alla deriva assolutistica per riconnettersi al “diritto dei padri”; la seconda, in nome del “nuovo”, sradicava ogni cosa sin dalle radici. E ciò era sommamente pericoloso.
Nonostante ciò, interpretare de Maistre significa non arrestarsi al pensiero controrivoluzionario e quindi ad un fronte oppositivo ma, paradossalmente, fare spazio a un pensiero sorgivo.
Nasce in un ambiente familiare colto e conservatore (da piccolo, la madre lo addormentava recitando brani di Racine). Poi l’incontro con la massoneria, su cui la critica si è capziosamente soffermata più del dovuto, il titolo ereditario di conte, le scuole dai gesuiti, lo studio delle lingue (inglese, spagnolo, latino, ma parlava discretamente anche il greco, il tedesco, il russo e l’ebraico), i corsi universitari in diritto, in un microcosmo sempre marchiato da questa solida convinzione di fondo: la vittoria del fronte illuministico non riguardava più solo il piano politico ma inaugurava un mondo nuovo: «A lungo non abbiamo capito la rivoluzione di cui siamo testimoni; a lungo l’abbiamo presa per un avvenimento Sbagliavano: essa è un’epoca». Cosicché quando si presentò la fase della Restaurazione intuì che la battaglia non era più confinata in fronti politici contrapposti perché ad essere sradicate erano oramai le fondamenta stesse della civiltà («nulla può cambiare in meglio tra gli uomini senza Dio»).
Ed è da questo punto di vista che la sua idea di sovranità e la spiegazione dei principi del diritto naturale immutabile avverso al diritto positivo che tutto assorbe, possono lasciare un’enorme eredità ai posteri. Sfrondata da taluni paradossi retorici e da nostalgie legittimiste la sua teologia politica mette al centro la persona – senza però scadere nell’antropocentrismo –, accorda una preminenza ad un ordine che preesiste al disordine che ne è la caduta («dove c’è un altare, lì c’è una civiltà»), alle tradizioni antiche, al primato dello spirito religioso e offre un suggestivo approccio al fenomeno della secolarizzazione.

