«D’Alema & C. hanno distrutto Mps»
Era da un po’ di tempo che non vi parlavamo del Monte dei Paschi. D’altronde, in questi mesi, la situazione si è profondamente modificata (speriamo in meglio). Il successo dell’aumento di capitale da 5 miliardi di euro dovrebbe aver definitivamente messo in sesto la banca senese che così ha potuto restituire 3 miliardi su 4,1 di Monti-bond (gli strascichi del recente passato e le rettifiche su crediti hanno continuato a far sentire il loro effetto negativo anche nel primo semestre 2014). Ora toccherà al presidente Alessandro Profumo e all’ad Fabrizio Viola rimetterla in marcia verso il profitto. L’aumento monstre ha sancito l’uscita di scena definitiva della Fondazione Mps dal ruolo di padre-padrone dell’istituto, anche se, grazie a un patto parasociale con la brasiliana Btg Pactual e e la messicana Fintech (che vincola il 9% del capitale), esercita un’influenza decisiva, ancorché non il controllo. Il primo socio individuale, con il 5%, è il fondo Usa York Capital Management. La presidente della Fondazione, Antonella Mansi, terminato il proprio compito di risanamento dei bilanci dell’ente, ha lasciato l’incarico e, come al solito, la politica senese non riesce a mettersi d’accordo sul nome del successore (in lizza Bettina Campedelli e Marcello Clarich).
Insomma, oggi il Monte è una public company (destinata, prima o poi, a un’aggregazione). Wall & Street vi hanno raccontato la sua fase più critica, cercando di storicizzare la questione e di mettere in rilievo, soprattutto, come l’intransigenza dell’Unione Europea e l’insipienza della classe dirigente italiana abbiano reso ancor più difficile la messa in sicurezza dell’istituto. Attualmente, è possibile illuminare ancor di più, se possibile, la corsa dissennata del Monte verso il precipizio.
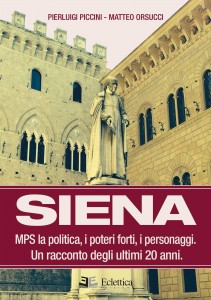 Da qualche tempo è uscito in libreria «Siena» (Eclettica edizioni, 176 pagine) un libro-intervista dell’ex sindaco del capoluogo toscano dal 1990 al 2001, Pierluigi Piccini, curato dal giornalista Matteo Orsucci. La figura di Piccini è emblematica per capire come i contorni della vicenda del Monte non siano esclusivamente finanziari, ma anche politici. Certo, la verità di Piccini è politica anch’essa ed è anche la testimonianza che arriva da una parte in causa nelle vicende di Mps precedenti l’acquisizione di Antonveneta che ne segnò il triste e veloce declino. Le parole dell’ex sindaco, però, consegnano al lettore alcune verità: l’ingerenza della politica a tutti i livelli (locale per le nomine della Fondazione e nazionale per l’imprimatur sulle strategie dell’istituto) è esiziale per la conduzione di un’impresa privata. In secondo luogo, il fallimento del piano di sviluppo del Monte non è solo il fallimento della sinistra che guida Siena da sempre, ma è anche il fallimento di un centrodestra che non ha mai denunciato queste stesse ingerenze e che si è accontentato di sedere come minoranza nei consigli della Fondazione e della banca.
Da qualche tempo è uscito in libreria «Siena» (Eclettica edizioni, 176 pagine) un libro-intervista dell’ex sindaco del capoluogo toscano dal 1990 al 2001, Pierluigi Piccini, curato dal giornalista Matteo Orsucci. La figura di Piccini è emblematica per capire come i contorni della vicenda del Monte non siano esclusivamente finanziari, ma anche politici. Certo, la verità di Piccini è politica anch’essa ed è anche la testimonianza che arriva da una parte in causa nelle vicende di Mps precedenti l’acquisizione di Antonveneta che ne segnò il triste e veloce declino. Le parole dell’ex sindaco, però, consegnano al lettore alcune verità: l’ingerenza della politica a tutti i livelli (locale per le nomine della Fondazione e nazionale per l’imprimatur sulle strategie dell’istituto) è esiziale per la conduzione di un’impresa privata. In secondo luogo, il fallimento del piano di sviluppo del Monte non è solo il fallimento della sinistra che guida Siena da sempre, ma è anche il fallimento di un centrodestra che non ha mai denunciato queste stesse ingerenze e che si è accontentato di sedere come minoranza nei consigli della Fondazione e della banca.
Un po’ di storia
Mps è stata fino all’altroieri la banca del «sistema-Siena», cioè i vertici del Pds-Ds-Pd decidevano le strategie della banca che, a sua volta, finanziava tutte le iniziative economiche e politiche del territorio e non. È una visione un po’ retorica ma che dà bene il quadro della situazione. Il fatto è che questo paradigma funziona per gli ultimi 20 anni e non per ciò che è accaduto anteriormente al 1992, quando la legge Amato-Draghi ha consentito la privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico (come le Casse di risparmio e il Monte) scorporando le Fondazioni dalla spa bancaria. Prima di quella data le banche erano sotto il ferreo controllo del governo, cioè della Democrazia Cristiana che scavalcava anche la Banca d’Italia nella decisione dei vertici dei singoli istituti dalle tre banche di interesse nazionale (Credit, Comit e Banco di Roma guidate dall‘Iri capeggiata per molti anni da Romano Prodi) fino alla più piccola Popolare di provincia. Agli alleati di governo della Dc restavano le briciole (qualcosa in più per il Psi di Bettino Craxi che era l’altro polo forte dell’alleanza) e, come in molte altre realtà, anche la massoneria aveva voce in capitolo.
 Pierluigi Piccini diventa sindaco di Siena quando la situazione sta cambiando. Le Fondazioni sono enti senza scopo di lucro cui viene affidata la totalità del controllo delle banche che poi devono essere privatizzate. Essendosi la politica trasferita dalle banche alle Fondazioni ed essendo quest’ultime a vocazione territoriale, nel caso di Siena per la prima volta gli eredi del Pci riescono a governare un istituto di credito. Il partito, che ha esperienza di finanza grazie alle Coop rosse, si comporta abbastanza responsabilmente e tutto sembra procedere come al solito: i bilanci sono soddisfacenti grazie all’opera di un ottimo manager come il dg Divo Gronchi e i vertici continuano a essere nominati dalla politica con il Pds che si è sostituito alla Dc.
Pierluigi Piccini diventa sindaco di Siena quando la situazione sta cambiando. Le Fondazioni sono enti senza scopo di lucro cui viene affidata la totalità del controllo delle banche che poi devono essere privatizzate. Essendosi la politica trasferita dalle banche alle Fondazioni ed essendo quest’ultime a vocazione territoriale, nel caso di Siena per la prima volta gli eredi del Pci riescono a governare un istituto di credito. Il partito, che ha esperienza di finanza grazie alle Coop rosse, si comporta abbastanza responsabilmente e tutto sembra procedere come al solito: i bilanci sono soddisfacenti grazie all’opera di un ottimo manager come il dg Divo Gronchi e i vertici continuano a essere nominati dalla politica con il Pds che si è sostituito alla Dc.
 Tutto cambia tra il 1998 e il 1999. Il Pds, questa volta, controlla anche Palazzo Chigi. Presidente del Consiglio è Massimo D’Alema che inaugura la stagione dei «capitani coraggiosi» sponsorizzando la scalata di Roberto Colaninno a Telecom e appoggiando la linea del governatore di Bankitalia, Antonio Fazio, favorevole a un’integrazione tra i grandi gruppi bancari italiani affinché essi non diventino preda di investitori esteri. È nel 1999 che si tentano, senza successo, le integrazioni fra UniCredit e Comit e fra Sanpaolo Imi e Banca di Roma. Entrambe le operazioni falliscono, ma danno vita a nuove fusioni come quella fra Banca Intesa e Comit e tra il Sanpaolo e Banco di Napoli, mentre la Banca di Roma di Cesare Geronzi è vivace nello shopping di istituti in difficoltà. Il Monte dei Paschi è tagliato fuori da questi circuiti e rischia di diventare irrilevante negli equilibri della finanza italiana. Massimo D’Alema lo sa bene e, come racconta Piccini, si spende affinché si aggreghi con l’altra grande «zitella» del sistema bancario italiano: la Banca Nazionale del Lavoro (Bnl). Piccini non è d’accordo e pagherà un prezzo elevato per il suo «no».
Tutto cambia tra il 1998 e il 1999. Il Pds, questa volta, controlla anche Palazzo Chigi. Presidente del Consiglio è Massimo D’Alema che inaugura la stagione dei «capitani coraggiosi» sponsorizzando la scalata di Roberto Colaninno a Telecom e appoggiando la linea del governatore di Bankitalia, Antonio Fazio, favorevole a un’integrazione tra i grandi gruppi bancari italiani affinché essi non diventino preda di investitori esteri. È nel 1999 che si tentano, senza successo, le integrazioni fra UniCredit e Comit e fra Sanpaolo Imi e Banca di Roma. Entrambe le operazioni falliscono, ma danno vita a nuove fusioni come quella fra Banca Intesa e Comit e tra il Sanpaolo e Banco di Napoli, mentre la Banca di Roma di Cesare Geronzi è vivace nello shopping di istituti in difficoltà. Il Monte dei Paschi è tagliato fuori da questi circuiti e rischia di diventare irrilevante negli equilibri della finanza italiana. Massimo D’Alema lo sa bene e, come racconta Piccini, si spende affinché si aggreghi con l’altra grande «zitella» del sistema bancario italiano: la Banca Nazionale del Lavoro (Bnl). Piccini non è d’accordo e pagherà un prezzo elevato per il suo «no».
Le operazioni «Banca del Salento» e «Mps Vita»
Siena, intanto, coltiva una strategia di crescita per linee esterne. Nel 1999 c’è una piccola preda che fa gola e che potrebbe permettere all’istituto il salto di qualità verso la nuova frontiera di Internet: è la Banca del Salento (Banca 121), piccolo istituto privato con sede a Lecce che, però, è fortissimo proprio sul nascente canale di distribuzione ed ha un’articolata rete di promotori finanziari in Puglia. Conquistarla non è facile perché tutte le grandi banche sono interessate. Racconta Piccini nel libro:
«Nel frattempo però a Siena, il direttore generale di Montepaschi Divo Gronchi, stava guardando con interesse da un po’ di tempo alla realtà di Banca 121. Un annetto prima aveva fatto invitare lo stesso De Bustis al Palio proprio come momento di raccordo. Ci fu un incontro tra l’allora presidente Fabrizi, il dg Gronchi e De Bustis a Rocca Salimbeni. De Bustis, che rappresentava gli interessi dei suoi soci, disse chiaro e tondo: ‘C’è in ballo un’esclusiva con Sanpaolo, ma se voi fate giungere un’offerta irrituale di 2500 miliardi i miei soci abbandoneranno l’ipotesi Fiat e venderanno a voi’. (…) Nel frattempo si era mossa anche la politica nazionale, Luigi Berlinguer telefonava ogni giorno affinché l’operazione la facesse Siena. A De Bustis poi, a livello pugliese, arrivarono anche i moniti del vescovo di Lecce che invitava a non fuggire
a Torino dove il Capitale avrebbe rovinato la banca del territorio».
L’acquisizione verrà formalizzata tra il dicembre del 1999 e il gennaio del 2000: il Monte dei Paschi comperò la Banca del Salento (poi Banca 121) per 2.500 miliardi di vecchie lire, grosso modo 1,3 miliardi di euro del nuovo conio. I multipli sono fantascientifici, ma si è in una fase di espansione dell’economia e comperare è costoso senza contare, come detto, che Banca 121 è già attiva sul canale Internet (è nata più o meno contemporaneamente a Fineco) e ha una rete strutturata di promotori. Oltre alla pressioni di Luigi Berlinguer (plenipotenziario del Pds per il territorio senese) e all’ovvio scontento della famiglia Agnelli (che a quell’epoca era l’azionista di «peso» del Sanpaolo), ciò che è risultato decisivo è anche il coinvolgimento di Vincenzo De Bustis, manager dell’istituto salentino che di lì a poco si trasferirà armi e bagagli a Siena.
«Nel 2000 poi il suo nome tornò in pista: invitai De Bustis a un pranzo nel quale parlammo della strategia della banca, il ruolo che essa doveva avere, l’ipotesi che già circolava di scalare Bnl. A maggio disse no all’offerta di Banca Intesa e venne a Siena. Restava il nodo di Divo Gronchi. Per non creare imbarazzi garantii personalmente i due: De Bustis avrebbe preso il posto di Gronchi e mi sarei impegnato a far modificare lo statuto della banca per la creazione della figura dell’amministratore delegato, carica che all’epoca non era prevista da conferire poi a Divo».
 Il dualismo non durò molto. De Bustis, nominato direttore generale nel giugno 2000, convisse con Gronchi per circa sei mesi. A fine anno, quest’ultimo lasciò il Monte per andare alla Banca Popolare di Vicenza. Anche se l’ingresso di De Bustis (oggi alla guida della Banca Popolare di Bari dopo essere stato il numero uno di Deutsche Bank in Italia) fu in qualche modo «sponsorizzato», come lascia intendere Piccini, la sua gestione fu buona. Prova ne fu l’affare realizzato con i francesi di Axa (da 12 anni azionisti stabili di Mps) per la cessione di Montepaschi Vita, il cui 50% fu rilevato dalla Fondiaria dei Ligresti per soli 200 milioni di euro poco più di un anno prima.
Il dualismo non durò molto. De Bustis, nominato direttore generale nel giugno 2000, convisse con Gronchi per circa sei mesi. A fine anno, quest’ultimo lasciò il Monte per andare alla Banca Popolare di Vicenza. Anche se l’ingresso di De Bustis (oggi alla guida della Banca Popolare di Bari dopo essere stato il numero uno di Deutsche Bank in Italia) fu in qualche modo «sponsorizzato», come lascia intendere Piccini, la sua gestione fu buona. Prova ne fu l’affare realizzato con i francesi di Axa (da 12 anni azionisti stabili di Mps) per la cessione di Montepaschi Vita, il cui 50% fu rilevato dalla Fondiaria dei Ligresti per soli 200 milioni di euro poco più di un anno prima.
«Il numero magico fu 1,2 miliardi di euro, ovvero la cifra a cui Axa comprò il tutto entrando di fatto nel cda di Montepaschi e facendo guadagnare non poco alla banca. Inutile dire che Ligresti da una parte, e i vertici di Unipol dall’altra erano furenti. La verità è che Unipol e Hopa erano un vero e proprio comitato d’affari all’interno del quale stavano cercando di inglobare anche Mps. Del resto ricordo un episodio: De Bustis mi ha raccontato che, davanti alla ipotesi di un aumento di capitale per Hopa, chiese in consiglio d’amministrazione la redditività di quella struttura. Fabrizi, uno che in cda non parlava mai, prese la parola e si spese in una filippica per sostenere la faccenda».
 In queste poche righe Piccini racconta i principali motivi (e, in controluce, si vedono anche quelli secondari) della rupture tra De Bustis e le istituzioni che controllavano il Monte dei Paschi. In primo luogo, cedendo il ramo Vita ai francesi, aveva fatto uno sgarbo alle Coop rosse che controllano la Unipol, allora guidata da Giovanni Consorte, irritando non poco il partito. In secondo luogo, De Bustis aveva questionato sul sostegno finanziario a Hopa, la holding bresciana di Chicco Gnutti (oggi fusa all’interno di Mittel, società di partecipazioni vicina al presidente del cds di Intesa, Giovanni Bazoli) che aveva accompagnato Colaninno nella scalata a Telecom e in difficoltà dopo l’uscita dall’operatore telefonico che costò una pesante minusvalenza nonostante i buoni uffici di Consorte che «aiutò» Tronchetti, Colaninno e Gnutti a trattare. Gnutti fu anche vicepresidente di Mps al 2003 al 2005. A proposito, qui si parla dello stesso Giovanni Consorte che nel 2005 ricevette la famosa telefonata del segretario dei Ds e oggi sindaco di Torino, Piero Fassino, che gli chiese «Abbiamo una banca?» dopo il lancio dell’offerta di Unipol su Bnl. Al partito la Banca Nazionale del Lavoro era sempre interessata…
In queste poche righe Piccini racconta i principali motivi (e, in controluce, si vedono anche quelli secondari) della rupture tra De Bustis e le istituzioni che controllavano il Monte dei Paschi. In primo luogo, cedendo il ramo Vita ai francesi, aveva fatto uno sgarbo alle Coop rosse che controllano la Unipol, allora guidata da Giovanni Consorte, irritando non poco il partito. In secondo luogo, De Bustis aveva questionato sul sostegno finanziario a Hopa, la holding bresciana di Chicco Gnutti (oggi fusa all’interno di Mittel, società di partecipazioni vicina al presidente del cds di Intesa, Giovanni Bazoli) che aveva accompagnato Colaninno nella scalata a Telecom e in difficoltà dopo l’uscita dall’operatore telefonico che costò una pesante minusvalenza nonostante i buoni uffici di Consorte che «aiutò» Tronchetti, Colaninno e Gnutti a trattare. Gnutti fu anche vicepresidente di Mps al 2003 al 2005. A proposito, qui si parla dello stesso Giovanni Consorte che nel 2005 ricevette la famosa telefonata del segretario dei Ds e oggi sindaco di Torino, Piero Fassino, che gli chiese «Abbiamo una banca?» dopo il lancio dell’offerta di Unipol su Bnl. Al partito la Banca Nazionale del Lavoro era sempre interessata…
Alla prima buona occasione si rinfacciò a De Bustis un grave peccato: i prodotti «My Way» e «4You», il primo originato da Banca 121 e il secondo da Mps, che venivano collocati come piani di accumulo previdenziali in fondi, ma che in realtà erano contratti di mutuo per l’acquisto di titoli e quote. La chiusura delle posizioni con i clienti che si trovavano inconsapevolmente una segnalazione alla Centrale Rischi di Bankitalia quando cercavano di stipulare un mutuo ipotecario sarebbero costate circa 500 milioni di euro. La banca ha sempre smentito la ricostruzione, ma nel libro Piccini afferma che con la spesa per le transazioni «si sarebbe potuta comprare un’altra banca». In ogni caso, a Siena non sapevano che farsene di un istituto orientato ai canali innovativi e, a fine 2002, Banca 121 fu incorporata nel Monte e trasformata in una banca per la clientela affluent. Ma la vera colpa di De Bustis fu un’altra.
Il niet di D’Alema e l’ascesa di Giuseppe Mussari
«Nell’estate del 2000 ero in ferie sul tranquillo litorale tirrenico, ricevo una telefonata dalla segretaria di D’Alema: era in Toscana, alla Festa dell’Unità a Pisa o Livorno, se non ricordo male, e mi disse che aveva assoluto bisogno di parlarmi. (…) Parlammo per un po’ nella sala ristorante appositamente tenuta deserta per noi, con me in costume, e lui in completo blu e camicia. Mi parlò, ovviamente, della Bnl e un sacco di altre cose che già in precedenza non aveva mancato di riferirmi, in un incontro, ai tempi in cui era stato segretario del partito. Gli dissi che non mi convinceva e che esistevano anche altre possibilità per la Banca, pur sempre in chiave aggregativa. Ma promisi comunque che avrei riflettuto sulla opportunità e sulla fattibilità dell’operazione. Ci salutammo su questo. Ma le pressioni arrivavano anche da Vincenzo Visco, allora ministro del Tesoro. Arrivavano anche da Giuliano Amato per interposta persona. Ricordo che lo stesso direttore generale del Monte, Divo Gronchi, mi disse più volte che Amato avrebbe desiderato che l’operazione Bnl venisse fatta. Le pressioni arrivavano anche da Antonio Fazio, col quale ci furono scontri molto duri».
 L’opposizione all’aggregazione con la Bnl costò cara a Pierluigi Piccini che l’anno successivo, al termine del suo terzo mandato da sindaco, era convinto di esser nominato presidente della Fondazione Mps. Mal gliene incolse perché proprio nel 2001 il governo presieduto da Giuliano Amato e con ministro del Tesoro Vincenzo Visco (il direttore generale era Mario Draghi) emanò una norma che proibiva la nomina negli enti bancari a coloro che avessero ricoperto incarichi istituzionali nei 12 mesi precedenti. Ovviamente, Piccini fu «risarcito» dai Ds con la nomina a vicedirettore generale di Mps Banque, la filiale francese del Monte con uno stipendio da top manager, ma fu allontanato da Siena per qualche anno. Il progetto alternativo di natura aggregante cui Piccini fa riferimento è una strategia, elaborata assieme a Goldman Sachs, secondo cui Mps avrebbe potuto essere un polo di attrazione per istituti medio-piccoli a forte vocazione locale che avrebbe consentito a Siena di ampliare la propria rete commerciale su tutto il territorio nazionale, un modello molto simile a quello di alcune grandi casse di risparmio tedesche.
L’opposizione all’aggregazione con la Bnl costò cara a Pierluigi Piccini che l’anno successivo, al termine del suo terzo mandato da sindaco, era convinto di esser nominato presidente della Fondazione Mps. Mal gliene incolse perché proprio nel 2001 il governo presieduto da Giuliano Amato e con ministro del Tesoro Vincenzo Visco (il direttore generale era Mario Draghi) emanò una norma che proibiva la nomina negli enti bancari a coloro che avessero ricoperto incarichi istituzionali nei 12 mesi precedenti. Ovviamente, Piccini fu «risarcito» dai Ds con la nomina a vicedirettore generale di Mps Banque, la filiale francese del Monte con uno stipendio da top manager, ma fu allontanato da Siena per qualche anno. Il progetto alternativo di natura aggregante cui Piccini fa riferimento è una strategia, elaborata assieme a Goldman Sachs, secondo cui Mps avrebbe potuto essere un polo di attrazione per istituti medio-piccoli a forte vocazione locale che avrebbe consentito a Siena di ampliare la propria rete commerciale su tutto il territorio nazionale, un modello molto simile a quello di alcune grandi casse di risparmio tedesche.
Anni dopo gli stessi esponenti politici gli confessarono che il provvedimento fu varato in ragione del suo diniego all’integrazione con Bnl. A Palazzo Sansedoni nel 2001 si insediò, così, Giuseppe Mussari che l’ex sindaco descrive così.
«Mussari faceva parte del partito e stava dentro a quel ‘cerchio magico’, usando un’espressione in voga oggi, che comprendeva Ceccherini e Ceccuzzi tra gli altri, e che era legato fortissimamente a Firenze e a Roma. Erano loro i garanti, gli irriducibili. Mussari era giovane, ambizioso, accentratore: chi meglio di un ‘fedele alla linea’ come lui poteva essere visto quale presidente che assecondasse i diktat romani?»
Le nozze fallite con Bnl
 Il clou del racconto finisce nel 2002, ma è negli anni successivi che la vicenda assumerà i contorni drammatici che noi tutti conosciamo. I tentativi di integrazione fra Mps e Bnl, infatti, naufragano abbastanza clamorosamente verso la fine del 2002. Secondo il racconto di Piccini, le resistenze dei vertici dell’istituto romano (il presidente Luigi Abete e l’ad Davide Croff), soprattutto sul tema della governance, sarebbero state decisive. Anche se pure a Siena c’era chi non faceva i salti di gioia dinanzi alla prospettiva di una fusione che avrebbe, sì, reso la Fondazione azionista di maggioranza, ma non più con quel 51% che Palazzo Sansedoni difenderà con le unghie e con i denti, in barba alla legge Amato-Draghi, fino a quando il fondo del baratro non sarà stato toccato.
Il clou del racconto finisce nel 2002, ma è negli anni successivi che la vicenda assumerà i contorni drammatici che noi tutti conosciamo. I tentativi di integrazione fra Mps e Bnl, infatti, naufragano abbastanza clamorosamente verso la fine del 2002. Secondo il racconto di Piccini, le resistenze dei vertici dell’istituto romano (il presidente Luigi Abete e l’ad Davide Croff), soprattutto sul tema della governance, sarebbero state decisive. Anche se pure a Siena c’era chi non faceva i salti di gioia dinanzi alla prospettiva di una fusione che avrebbe, sì, reso la Fondazione azionista di maggioranza, ma non più con quel 51% che Palazzo Sansedoni difenderà con le unghie e con i denti, in barba alla legge Amato-Draghi, fino a quando il fondo del baratro non sarà stato toccato.
Con Piccini estromesso a priori (nel 2004 sarà anche espulso dal partito per aver partecipato alle elezioni con una lista civica concorrente dei Ds) e De Bustis «cacciato» (nonostante avesse condotto le trattative con Bnl, negli ultimi periodi del suo incarico si era dimostrato piuttosto freddo nei confronti dell’operazione), Giuseppe Mussari – in tandem con il presidente della banca Pierluigi Fabrizi (del quale prenderà il posto nel 2006) – aveva ormai campo libero per realizzare il sogno senese di grandeur. Non a caso, tra la fine del 2003 e gli inizi del 2004, le parti cominciarono a riavvicinarsi. È bene ricordarlo: Mps e Bnl erano sole in un’epoca in cui tutte le concorrenti crescevano per linee esterne. Le sovrapposizioni di filiali, all’epoca, erano relativamente poche e, dunque, i presupposti per una buona operazione c’erano tutti (ancorché il progetto fosse sostenuto soprattutto da disegni politici). Anche Piccini, a distanza di un paio d’anni, aveva cambiato idea e nel libro lo afferma esplicitamente.
«Fondere il Montepaschi di allora con la Bnl significava creare un colosso fatto di credito, finanza, assicurazioni e depositarlo di fatto nelle mani del segretario del maggior partito della sinistra. I fronti erano due a livello nazionale ed anche a Siena: D’Alema che spingeva per la scalata, Veltroni, e quindi Prodi, che la contrastavano, almeno nella seconda fase».
 Romano Prodi, candidato in pectore del centrosinistra a Palazzo Chigi, nel 2005 avrebbe contribuito materialmente a ostacolare la fusione perché sgradita (andò diversamente l’anno successivo quando benedisse le nozze Intesa-Sanpaolo e UniCredit-Capitalia). Ma Piccini avanza anche un’altra ipotesi. Giuseppe Mussari, vero dominus del Monte, avrebbe potuto agire in autonomia dalla politica (o quantomeno assecondare i desiderata dalemiani) e portare avanti le trattative. Non lo fece. «Non è che Mussari avesse già raggiunto un accordo di massima per l’operazione Antonveneta?», si chiede l’ex sindaco insinuando il sospetto (tutto da verificare) che gli spagnoli del Santander, che nel 2007 acquistarono Antonveneta dopo lo spacchettamento di Abn Amro, avessero intenzione di mettere i bastoni tra le ruote ai concorrenti iberici del Bbva, allora azionisti di Bnl. E se questi fossero i motivi (anche se è difficile pensare che Santander nel 2005 sapesse cosa avrebbe fatto di lì a due anni), è lecito chiedersi, come fa Piccini, perché Mussari avesse rifiutato, sempre nel 2002 una proposta di acquistare Antonveneta, avanzatagli da Chicco Gnutti, che con Hopa ne era socio, a condizioni molto più vantaggiose degli oltre 10 miliardi spuntati dagli spagnoli nel 2007. Se la politica si fosse tenuta fuori dalla vicenda, probabilmente questi interrogativi sarebbero superflui.
Romano Prodi, candidato in pectore del centrosinistra a Palazzo Chigi, nel 2005 avrebbe contribuito materialmente a ostacolare la fusione perché sgradita (andò diversamente l’anno successivo quando benedisse le nozze Intesa-Sanpaolo e UniCredit-Capitalia). Ma Piccini avanza anche un’altra ipotesi. Giuseppe Mussari, vero dominus del Monte, avrebbe potuto agire in autonomia dalla politica (o quantomeno assecondare i desiderata dalemiani) e portare avanti le trattative. Non lo fece. «Non è che Mussari avesse già raggiunto un accordo di massima per l’operazione Antonveneta?», si chiede l’ex sindaco insinuando il sospetto (tutto da verificare) che gli spagnoli del Santander, che nel 2007 acquistarono Antonveneta dopo lo spacchettamento di Abn Amro, avessero intenzione di mettere i bastoni tra le ruote ai concorrenti iberici del Bbva, allora azionisti di Bnl. E se questi fossero i motivi (anche se è difficile pensare che Santander nel 2005 sapesse cosa avrebbe fatto di lì a due anni), è lecito chiedersi, come fa Piccini, perché Mussari avesse rifiutato, sempre nel 2002 una proposta di acquistare Antonveneta, avanzatagli da Chicco Gnutti, che con Hopa ne era socio, a condizioni molto più vantaggiose degli oltre 10 miliardi spuntati dagli spagnoli nel 2007. Se la politica si fosse tenuta fuori dalla vicenda, probabilmente questi interrogativi sarebbero superflui.
Wall & Street





