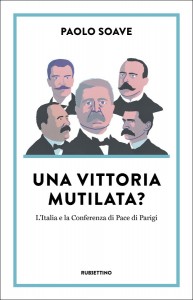Parigi 1919. Una vittoria mutilata
La discussa e discutibile visita del presidente Mattarella lo scorso luglio a Trieste culminata con lo strambo omaggio ai quattro terroristi slavi del Tigr — fucilati nel 1930 dopo una scia di sanguinosi attentati contro obiettivi civili italiani — e le commemorazioni più o meno felici dell’impresa dannunziana di Fiume hanno fugacemente riportato l’attenzione sulle intricate vicende del confine orientale d’Italia. Come al solito i media ci hanno afflitto con narrazioni superficiali quando non fuorvianti, riducendo la questione adriatica in schematismi talvolta nostalgici e retorici o, troppo spesso, incredibilmente auto colpevolizzanti. Risultato: la tragedia novecentesca delle terre istriane e dalmate rimane il terreno di scontro per opposte tifoserie. Uno sterile gioco tra struggimenti per la piccola patria perduta e insopportabili negazionismi.
Fortunatamente la ricerca storica, seppur faticosamente, prosegue con lavori innovativi e nuove chiavi interpretative che permettono di comprendere lo “zeitgeist” e cogliere la somma delle formidabili implicazioni politiche ed economiche che determinarono (e ancor oggi determinano) confini e memorie. Di assoluto rilievo è il nuovo libro di Paolo Soave “Una vittoria mutilata?” (Rubettino pp.157, euro 14,00) che analizza uno dei nodi centrali quanto scomodi della nostra vicenda unitaria, ovvero la contradditoria (e non pagante) partecipazione nel 1919 dell’Italia alla Conferenza di Versailles, esiziale redde rationem fissato dalle potenze euro-atlantiche ai nemici sconfitti e brusco rappel à l’ordre per agli alleati minori: Italia, Belgio, Serbia, Grecia, Romania, Giappone, Portogallo. In guerra presenze necessarie e, talvolta, indispensabili, in pace fastidiosi coriandoli. Da premiare (Belgio e Giappone), usare (Serbia e Grecia) o marginalizzare. Fu il caso dell’Italia.
Soave, brillante docente di Storia delle Relazioni Internazionali, affronta il problema italiano con minuzia archivistica, larghezza di visione e (dato non scontato per un accademico…) scrittura fluida, individuando con precisione le perduranti opacità nel rapporto (sempre disuguale) tra Roma e le capitali occidentali.
Il punto di partenza è il Trattato di Londra del 1915, la travagliata decisione della rottura della “Triplice” e l’adesione all’”Intesa” su un accordo segreto che assicurava al regno sabaudo non solo l’arco Trento-Trieste ma anche e soprattutto il controllo dell’Adriatico, un protettorato sull’Albania, il riconoscimento del possesso del Dodecaneso e ampliamenti in Asia minore, diritti sul Mar Rosso, più vaghe promesse per l’amministrazione del Canale di Suez e sull’Africa tedesca. Sulla carta un magnifico bottino per la piccola Italia — “grande potenza solo a titolo di cortesia” come ricordava Gioacchino Volpe — ma anche un grande azzardo. Salandra, Sonnino e Vittorio Emanuele (protagonista non secondario) non ebbero troppi dubbi e imposero ad un Paese ancora largamente neutralista l’entrata in guerra. Come nota l’autore uno spregiudicato “giro di valzer” in cui s’intrecciava la tradizionale diplomazia “anfibia” sabauda con la ripresa «della fase espansiva della politica estera unitaria avviata nel 1911 da Giolitti con la conquista della “quarta sponda”. Impegnando le armi si sarebbe espresso il tentativo dell’Italia liberale di costruire una patria comune e una sintesi di nazione, libertà e modernità».
Poi il 24 maggio. Il Carso, Gorizia, le Alpi, Caporetto, il Grappa e il Piave e, infine, Vittorio Veneto. Seicentottantamila morti, un milione e più di mutilati su 5.240.000 mobilitati, il 13,78 della popolazione. Un conflitto lungo, sanguinoso che mise a durissima prova l’intero Paese, suscitando energie impreviste all’interno — un inedito patriottismo diffuso, i “ragazzi del ‘99” e l’arditismo — e fortissime diffidenze all’esterno. Puntualmente i franco-britannici sottostimarono lo sforzo militare ed economico del regno e il fronte italiano venne pervicacemente ignorato dalla grande stampa alleata. Con un’unica eccezione Rudyard Kipling. Nel 1917 l’autore del “Libro della Giungla”, premio Nobel per la Letteratura, raggiunse agli alpini sulle vette delle Alpi Giulie e Carniche e si appassionò ai soldati di montagna diventandone uno dei cantori più originali con un libro-testimonianza “La guerra nelle montagne”. Una singolarità. Ancora oggi per la copiosa storiografia anglo-sassone sulla Grande Guerra il teatro italiano rimane un fatto secondario e l’impegno militare quasi risibile. Lo confermano, una volta di più, le velenose righe di Margaret MacMillian nel suo poderoso volume “Parigi 1919”, dedicato appunto a Versailles. Per l’ex rettrice del Trinity College «i soldati italiani, mal guidati e peggio equipaggiati, erano stati massacrati nel corso delle battaglie svoltesi sulle Alpi, finché l’esercito era crollato a Caporetto nel 1917. Nel 1918, di fronte a oltre mezzo milioni di morti e un numero ancora maggiore di feriti gravi, la domanda che cominciava a circolare era: a che scopo?». Per la MacMillian e i suoi dotti colleghi la resistenza accanita sul Piave e il Grappa, la “guerra bianca” sull’Adamello e dintorni, le battaglie del Solstizio, il Col Moschin, le imprese di Rizzo, l’armistizio di Villa Giusti nulla contano. Nulla pesano.
Una visione daltonica che, come ci avverte Soave, arriva da lontano, dall’incessante lavorio delle cancellerie durante il proseguirsi del conflitto. Mentre le “tempeste d’acciaio” massacravano un’intera generazione, felpati diplomatici, astuti capitalisti e callidi ministri preparavano il dopoguerra, il nuovo ordine post bellico. Un gioco sottile quanto micidiale che non prevedeva le rivendicazioni italiane. Sceso il silenzio sui campi di battaglia a Versailles, riprendendo il colonello T. E. Lawrence, «gli uomini vecchi decisero la loro pace». Purtroppo a rappresentare a Parigi l’Italia vittoriosa di Diaz e di D’Annunzio arrivarono uomini culturalmente ancor più vecchi e, soprattutto, decisamente più inadeguati dei loro agguerriti colleghi: il francese Clemenceau, il britannico Lloyd George, lo statunitense Wilson. Il peggiore.
Una volta seduti sulle comode poltrone della “galleria degli specchi”, lustro della reggia di Luigi XIV, Orlando e Sonnino si resero presto conto di contare poco o niente. Gli alleati accusarono l’Italia d’egoismo, sminuirono il nostro apporto alla vittoria, si dimenticarono con facilità estrema dei patti londinesi, rintuzzarono ogni appetito coloniale e — con il sostegno dell’italofobico Wilson — cercarono di bloccare ogni ambizione italiana sull’Adriatico e nei Balcani. Fiume compresa. La nuova Jugoslavia monarchica divenne il contraltare, l’adeguato antemurale ai progetti di Roma.
Per i “grandi” lo Stivale doveva rassegnarsi ad un ruolo da junior partner, rinunciare ad ogni ipotesi d’autosufficienza economica e a miraggi d’autonomia politica e accettare una sorta di sovranità limitata. I delegati — già scossi dalla ventura dannunziana a Fiume, preoccupati dai conflitti sociali in atto e angosciati dai tanti debiti — non furono all’altezza della situazione e inanellarono una serie di errori che indebolirono ulteriormente la già debole posizione dell’Italia. Alla fine, come stigmatizza l’autore, la conferenza si ridusse ad un problema di rapporti di forza tra ineguali, un confronto impari che un personale politico ormai logorato non poteva reggere. Salandra e Sonnino strillarono, minacciarono, partirono e poi tornarono e, infine, firmarono. In patria il mito della “vittoria mutilata” divenne facile argomento per le opposizioni nazionaliste — D’Annunzio si scagliò contro “i divoratori di carne umana” — e alimentò il nascente fascismo che nel ventennio alternò in politica estera revisionismo e anti revisionismo. I risultati sono noti e ampiamente indagati.
Come avverte Paolo Soave, a distanza di un secolo il convegno di Versailles rimane un paradigma per tutti coloro — invero pochi — che si preoccupano e si interrogano sul ruolo internazionale dell’Italia nel terzo millennio. Evaporate le velleità imperiali, rimangono sempre irrisolti i rapporti con gli alleati (veri o presunti) e il significato della nostra collocazione nell’Adriatico, nel Mediterraneo (più o meno allargato), nei Balcani, in Africa. Oggi come nel 1919.